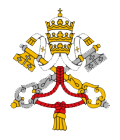NICEA 325-2025 – UN MOMENTO D'ORO PER L'UNITÀ ECUMENICA
Conferenza per l’Incontro “1700 anni dal Concilio di Nicea” al Meeting di Rimini
26 agosto 2025
Il movimento ecumenico conosce non solo strade principali che, ampie e lineari, conducono a un futuro luminoso. Esso incontra spesso anche strade secondarie più strette, così come deviazioni e svolte. Naturalmente, non mancano occasioni ed eventi particolarmente favorevoli che si rivelano fruttuosi per il futuro. Un momento d’oro per l’unità ecumenica, per tutta la cristianità, è certamente il 1700° anniversario del primo Concilio ecumenico tenutosi a Nicea nel 325. La commemorazione di questo evento significativo per la storia della Chiesa offre importanti impulsi ecumenici, soprattutto da tre punti di vista.
Il Credo cristiano comune
In una prospettiva ecumenica, le questioni dottrinali che il Concilio dovette affrontare in quel periodo sono di primaria importanza. Esse furono sollevate all'inizio del IV secolo, principalmente nella parte orientale dell'impero romano, dal presbitero alessandrino Ario. Questo teologo difendeva un monoteismo rigoroso nello spirito del pensiero filosofico di allora, guidato dalla convinzione che potesse esserci soltanto un unico Dio. Secondo Ario, quindi, Gesù Cristo non poteva essere assimilato a Dio, perché facente parte del creato, sebbene fosse una creatura del tutto speciale. Di conseguenza, nella visione di Ario, Gesù Cristo non era "Figlio di Dio" nel vero senso della parola, ma solo un essere intermediario di cui Dio si serviva nella creazione del mondo e nelle sue relazioni con l'umanità.
Questa situazione mostra che, a quel tempo, la questione di chi fosse Gesù Cristo per i cristiani era diventata un problema fondamentale. La disputa ruotava principalmente intorno alla possibilità o meno di conciliare la professione di fede in Gesù Cristo quale Figlio di Dio con la fede altrettanto cristiana nell'unico Dio, conforme alla confessione monoteistica. Poiché questo grave problema di fede non poteva essere risolto nei sinodi locali della Chiesa di Alessandria, l'imperatore Costantino convocò i vescovi in un sinodo di tutta la Chiesa nella città di Nicea, in Asia Minore. Dei 1.800 vescovi invitati, solo 318 parteciparono, tra cui Nicola di Mira, ancora oggi molto venerato, e Atanasio, in seguito riconosciuto Dottore della Chiesa.
Nella "Lettera del Sinodo di Nicea agli Egiziani", i vescovi annunciarono di aver deciso all'unanimità di considerare anatema la "dottrina contraria alla fede" di Ario, "così come le affermazioni e gli appellativi blasfemi con cui insultava il Figlio di Dio". I vescovi rifiutarono così il modello di monoteismo strettamente filosofico sostenuto da Ario, opponendo ad esso la professione di fede secondo cui l'unico Signore Gesù Cristo è il Figlio di Dio: "nato dal Padre come Unigenito, ovvero dalla sostanza del Padre, Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo del quale tutte le cose sono state create in cielo e sulla terra".
L'espressione chiave in questa confessione cristologica è il termine greco "homoousios", che significa che Gesù Cristo, in quanto Figlio di Dio, è "consustanziale" al Padre celeste. I Padri conciliari espressero così la loro ferma convinzione di fede secondo cui la natura di Gesù Cristo è decisamente associabile a Dio e non al creato; egli è quindi veramente l'unigenito Figlio di Dio. I Padri conciliari riconobbero dunque con estrema precisione l'aspetto incomparabilmente nuovo e unico che si manifesta nella relazione tra Figlio e Padre.
La confessione cristologica al Concilio di Nicea avrebbe potuto porre fine alla controversia del IV secolo. Tuttavia, la storia mostra che la disputa si riaccese dopo il Concilio. Anche i successori dell'imperatore Costantino, in particolare suo figlio, l'imperatore Costanzo, contribuirono in modo significativo a ciò, perseguendo una decisa politica di allontanamento dal Credo del Concilio di Nicea. Inoltre, la confessione cristologica di Nicea rappresenta una tappa importante, ma non ancora il traguardo, sul cammino verso il grande Credo di Costantinopoli del 381. Infatti, il Concilio di Nicea definì la fede in Gesù Cristo, ma la professione di fede nello Spirito Santo fu fissata solo dal Concilio di Costantinopoli, che definì il dogma della divina Trinità nella forma specificamente cristiana del monoteismo.
Nel Credo niceno-costantinopolitano risiede il fondamento della fede comune a tutti i cristiani. Mentre il Credo apostolico, diffuso nella Chiesa d'Occidente, non ha trovato accoglienza liturgica nelle Chiese orientali, il Credo niceno-costantinopolitano è stato accettato all'unanimità nella cristianità ortodossa, cattolica e protestante. Pertanto, come ha sottolineato l'ecumenista protestante Wolfhart Pannenberg, esso è "legato a una pretesa di validità ecclesiale universale ed è stato accolto anche dalla Chiesa primitiva come vincolante per tutti i cristiani".[1]
Esso rappresenta quindi il più forte vincolo ecumenico della fede cristiana ed il segnavia decisivo verso l'unità della Chiesa. Per il ripristino dell'unità della Chiesa è necessario un accordo sul contenuto essenziale della fede, non solo tra le Chiese e le Comunità ecclesiali di oggi, ma anche tra la Chiesa di oggi e la Chiesa del passato e, soprattutto, le sue origini apostoliche. L'unità della Chiesa non potrà mai essere altro che unità nella fede apostolica, in quella fede che viene trasmessa e affidata a ogni nuovo membro del Corpo di Cristo nel battesimo. Si rinnova così la consapevolezza che l'ecumenismo è fondamentalmente una questione di fede e che l'unità della Chiesa non potrà essere raggiunta prescindendo dalla verità della fede.
Il Concilio di Nicea assume inoltre una particolare importanza ecumenica per il fatto di essersi svolto in un'epoca in cui la cristianità non era ancora ferita dalle numerose divisioni che si verificarono in seguito. La sua professione di fede cristologica è quindi comune a tutte le Chiese e le Comunità ecclesiali cristiane e le unisce tutt’oggi nella confessione condivisa. Grandissima è pertanto la sua rilevanza ecumenica. È quindi auspicabile che il 1700° anniversario del Concilio di Nicea venga celebrato da tutta la cristianità nello spirito ecumenico e che il suo Credo cristologico venga riaffermato nella comunione ecumenica.
La riflessione sul Concilio di Nicea non può, naturalmente, essere solo di interesse storico. Piuttosto, la sua confessione cristologica ha un’importanza duratura nella situazione attuale della Chiesa e dell'ecumenismo. Chiunque guardi con onestà al mondo di fede odierno deve riconoscere che ci troviamo in una situazione simile a quella del IV secolo, nella misura in cui è constatabile una forte ricomparsa delle tendenze ariane. Infatti, non pochi cristiani oggi sono toccati da tutte le dimensioni umane e storiche della figura di Gesù di Nazareth, eppure la confessione di fede secondo cui Gesù di Nazareth è l'unigenito Figlio del Padre, presente tra noi come il Risorto, ovvero la fede cristologica della Chiesa, è per loro una fonte di grande difficoltà. Ravvivare la professione di fede in Gesù Cristo, per imparare a vederlo di nuovo in tutta la sua grandezza e bellezza, è dunque un comandamento dell’ora presente, che dobbiamo adempiere nella comunione ecumenica.
La dimensione pastorale della data di Pasqua
Il Concilio di Nicea riveste una particolare importanza dal punto di vista ecumenico anche perché, oltre al Credo, affrontò tematiche canoniche e disciplinari, presentate in venti canoni che forniscono preziosi spunti relativi a problematiche pastorali e difficoltà canoniche della Chiesa all'inizio del IV secolo. La questione pastorale più significativa fu quella della data di Pasqua. Ciò mostra che la data di Pasqua era controversa già nella Chiesa primitiva e che i cristiani di diverse regioni celebravano la Pasqua in date diverse. Soprattutto in Asia Minore, i cristiani festeggiavano la Pasqua il 14 di Nisan, parallelamente alla Pasqua ebraica; per questo venivano chiamati "quartodecimani". In Siria e in Mesopotamia, la celebravano invece la domenica successiva alla Pasqua ebraica, ed erano detti "proto-pascisti".
Alla luce di tale situazione, al Concilio di Nicea va riconosciuto il merito di aver tentato di trovare una regola uniforme per la data della Pasqua, come viene evidenziato nella "Lettera del Sinodo di Nicea agli Egiziani" con le seguenti parole: "tutti i fratelli e le sorelle d'Oriente che finora hanno celebrato con gli ebrei, d'ora in poi celebreranno la Pasqua in accordo con i romani, con voi e con tutti noi che l'abbiamo mantenuta con voi da tempo immemorabile”. In primo luogo, con tale decisione, il Concilio fissò la data della celebrazione della Pasqua la domenica successiva al primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera. In secondo luogo, stabilì che la determinazione della data esatta della Pasqua non dovesse dipendere dal calcolo ebraico e, di conseguenza, che la Pasqua dovesse essere celebrata più tardi della Pasqua ebraica.
Una nuova situazione rispetto alla data di Pasqua si verificò nella storia della cristianità quando, nel XVI secolo, Papa Gregorio XIII introdusse il calendario gregoriano, che prese il suo nome, con una riforma fondamentale del calendario. Le Chiese in Occidente calcolano la data della Pasqua conformemente ad esso, mentre le Chiese in Oriente celebrano ancora in gran parte la Pasqua secondo il calendario giuliano, in uso in tutta la Chiesa prima della riforma gregoriana.
Nel corso della storia fino ad oggi, sono state discusse varie proposte per superare la diversità delle date di Pasqua e per stabilire una data comune. Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, essa aveva già preso posizione durante il Concilio Vaticano Secondo in un'appendice della Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, dichiarando di non avere nulla in contrario “a che la festa di Pasqua venga assegnata ad una determinata domenica nel calendario gregoriano, purché vi sia l'assenso di coloro che ne sono interessati, soprattutto i fratelli separati dalla comunione con la Sede apostolica”[2]. Da allora, Papa Francesco e, più recentemente, Papa Leone XIV, si sono espressi al riguardo con la stessa apertura.
Gli sforzi compiuti per trovare una data di Pasqua comune corrispondono a un'importante priorità pastorale, soprattutto nei matrimoni e nelle famiglie di diverse confessioni e in considerazione della grande mobilità delle persone al giorno d’oggi. In particolare, una data di Pasqua comune potrebbe essere un segno più credibile della profonda convinzione di fede cristiana secondo cui la Pasqua non è solo la festa più antica, ma è anche la festa più importante della cristianità. Il 1700° anniversario del Concilio di Nicea offre dunque un'occasione proficua per rinnovare gli sforzi volti a trovare, nella comunione ecumenica, una data di Pasqua comune e per riflettere nuovamente sulla decisione del Concilio di Nicea al riguardo, alla luce delle condizioni attuali. La regola fondamentale dovrebbe essere quella di pervenire a una data comune senza provocare nuove tensioni e divisioni all'interno delle singole Chiese e all'interno della comunità ecumenica.
Deliberazione e processo decisionale sinodale
In una prospettiva ecumenica, il Concilio di Nicea è significativo anche perché documenta il modo in cui furono discusse e decise le controverse questioni di allora intorno al Credo e alla disciplina ecclesiastica. Il Credo del Concilio di Nicea non fu semplicemente il risultato di una riflessione teologica, ma fu piuttosto l'espressione dello sforzo comune compiuto dai vescovi, in maniera sinodale, per trovare una formulazione ortodossa e dossologicamente adeguata della fede cristiana. Eusebio, primo storiografo della Chiesa e lui stesso Padre conciliare, che vedeva nel Concilio di Nicea una nuova Pentecoste, ricordò che in esso si radunarono i primi servi di Dio "da tutte le Chiese d'Europa, d'Africa e d'Asia"[3]. Pertanto, il Concilio di Nicea può essere considerato l'inizio, a livello di Chiesa universale, del metodo sinodale applicato alla deliberazione e al processo decisionale.
Il 1700° anniversario del Concilio di Nicea dovrebbe quindi essere inteso anche come un invito e come una sfida a imparare dalla storia della Chiesa e, nella comunione ecumenica, ad approfondire l'idea sinodale, a radicarla nella vita ecclesiale e a renderla feconda negli sforzi ecumenici. Di fatti, il movimento ecumenico può progredire sulla via dell'unità della Chiesa solo se questa via viene intrapresa insieme e dunque in modo sinodale. D'altra parte, l'attuale rivitalizzazione della dimensione sinodale della Chiesa può essere potenziata anche attraverso relazioni ecumeniche. Poiché la sinodalità è stata e continua ad essere sviluppata in modi diversi nelle varie Chiese e Comunità ecclesiali, possiamo imparare molto gli uni dagli altri al riguardo, nei dialoghi ecumenici. L'odierno approfondimento dello stile di vita sinodale può essere arricchito dalle esperienze e dagli sforzi di riflessione teologica delle varie Chiese.
Ciò vale in particolare per il dialogo cattolico-ortodosso, che ha portato alla pubblicazione dell'importante documento "Le conseguenze ecclesiologiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa: comunione ecclesiale, conciliarità e autorità"[4] durante l'Assemblea plenaria di Ravenna del 2007. Questo ponderoso documento rispecchia la duplice convinzione teologica secondo la quale sinodalità e primato sono interdipendenti nel senso che non può esserci primato senza sinodalità e non può esserci sinodalità senza primato, e che questa interdipendenza deve essere realizzata a tutti i livelli della Chiesa: locale, regionale e universale. Il documento di Ravenna va considerato come una pietra miliare, sulla cui base sono stati elaborati e pubblicati altri due importanti documenti: "Sinodalità e primato nel primo millennio: verso una comune comprensione nel servizio all'unità della Chiesa" (Chieti 2016)[5] e "Sinodalità e primato nel secondo millennio e oggi" (Alessandria 2023).
Sulla via del ripristino dell'unità della Chiesa in Oriente e in Occidente, si possono compiere ulteriori passi importanti se Oriente e Occidente si impegnano entrambi ad avvicinarsi, mostrandosi disposti a imparare gli uni dagli altri. Non si tratta di trovare un compromesso basato sul minimo comune denominatore. Piuttosto, si tratta di far dialogare i punti di forza di una parte con quelli dell'altra, nel desiderio di apprendere dalle esperienze altrui. In questo senso, il Gruppo di Lavoro ortodosso-cattolico Sant'Ireneo ha indicato sinteticamente un'importante via da seguire nel suo studio "Al servizio della comunità": "In particolare, le Chiese devono impegnarsi a raggiungere un migliore equilibrio tra sinodalità e primato a tutti i livelli della vita ecclesiale, soprattutto rafforzando le strutture sinodali nella Chiesa cattolica e accettando, da parte della Chiesa ortodossa, un qualche primato all'interno della comunione mondiale delle Chiese".[6]
Spetta alle Chiese ortodosse indicare come intendono rispondere a questo postulato. Da parte della Chiesa cattolica, è chiaro che essa ha imparato molto dalle Chiese ortodosse nel potenziare uno stile di vita sinodale. Papa Francesco si è detto convinto che la pratica della sinodalità e la riflessione su di essa, anche nella Chiesa cattolica, debbano svolgersi in una prospettiva ecumenica, essendo l’impegno a edificare una Chiesa sinodale “gravido di implicazioni ecumeniche"[7]. E Papa Leone XIV ha espresso la sua intenzione di proseguire su questa strada già nella sua prima benedizione dopo l'elezione al soglio pontificio, con la seguente assicurazione: "Vogliamo essere una Chiesa sinodale"[8]. Non può essere altrimenti, se prendiamo sul serio quanto affermato dal Dottore della Chiesa Crisostomo, secondo cui "Chiesa" è un nome "che indica un cammino comune", e Chiesa e Sinodo sono quindi "sinonimi"[9].
In sintesi, l’importanza ecumenica del Concilio di Nicea risiede nell’opportunità di rinnovare e approfondire la sua professione di fede, nello sforzo pastorale di trovare una data comune di Pasqua e nella rivitalizzazione di uno stile di vita sinodale all’interno delle varie Chiese. Se queste priorità saranno perseguite con determinazione, il 1700° anniversario del Concilio di Nicea, di per sé una pietra miliare nella storia della Chiesa, si rivelerà un momento d’oro per l'unità ecumenica. Allora, come ha sottolineato Papa Leone XIV, il Concilio di Nicea non sarà “solo un evento del passato, ma una bussola che deve continuare a guidarci verso la piena unità visibile dei cristiani”[10].
[1] W. Pannenberg, Die Bedeutung des Bekenntnisses von Nicaea-Konstantinopel für den ökumenischen Dialog heute, in: Ders., Beiträge zur Systematischen Theologie. Band 3: Kirche und Ökumene (Göttingen 2000) 194-204, zit. 197.
[2] Appendice: Dichiarazione del Concilio Vaticano Secondo sulla riforma del calendario.
[3] Eusebio, Vita Const. III, 7.
[4] Dokumentiert in: J. Oeldemann, F. Nüssel, U. Swarat, A. Vletsis (Hrsg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. Band 4: 2002-2010 (Paderborn – Leipzig 2012) 833-848.
[5] Dokumentiert in: J. Oeldemann, F. Nüssel, U. Swarat, A. Vletsis (Hrsg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. Band 5: 2011-2019 (Paderborn – Leipzig 2021) 1006-1014.
[6] Im Dienst an der Gemeinschaft. Das Verhältnis von Primat und Synodalität neu denken. Eine Studie des Gemeinsamen orthodox-katholischen Arbeitskreises St. Irenäus (Paderborn 2018) 94.
[7] Francesco, Discorso in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015.
[8] Leone XIV, Prima Benedizione "Urbi et Orbi", 8 maggio 2025.
[9] Crisostomo, Explicatio in Ps 149, in: PG 55, 493.
[10] Leone XIV, Discorso ai partecipanti al Simposio commemorativo del 1700° anniversario del Concilio di Nicea, 7 giugno 2025.