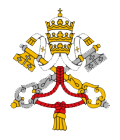Conferenza in occasione del Centenario della Casa Santa Birgitta
dell’Ordine del Santissimo Salvatore di S. Brigida a Lugano
21 settembre 2024
LE SFIDE DELL’ECUMENISMO
NEL CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA
1. Interdipendenza tra cammino sinodale e cammino ecumenico
“Il cammino della sinodalità, che la Chiesa cattolica sta percorrendo, è e dev’essere ecumenico, così come il cammino ecumenico è sinodale.”[1] Con queste parole, Papa Francesco si è riferito in maniera eloquente all’interdipendenza tra il cammino sinodale e il cammino ecumenico. Per comprendere meglio il significato di sinodalità e le sfide ecumeniche ad essa associate, è opportuno partire dalle radici linguistiche della parola “sinodo”. Questa parola è composta dai termini greci “hodos” (= cammino) e “syn” (= con) ed indica il fatto di mettersi in cammino insieme ad altri. Nell’accezione cristiana, la parola “sinodo” designa la via comune di coloro che credono in Gesù Cristo, il quale ha rivelato e chiamato se stesso via, ovvero “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6). All’origine, la religione cristiana era quindi designata come “via” e i cristiani nella sequela di Cristo erano detti “seguaci della Via” (At 9,2). Rimanendo fedele a questa origine, Papa Benedetto XVI ha voluto chiamare la Chiesa “comunità di fede in cammino”[2]. Nella stessa ottica, l’eminente Dottore della Chiesa San Giovanni Crisostomo poté affermare che Chiesa è un nome “che significa un cammino comune” e che, pertanto, Chiesa e sinodo sono “sinonimi”[3].
La parola “sinodalità” è dunque tanto antica e fondamentale quanto la parola “chiesa” e allude a una dimensione intrinseca della Chiesa. Essa comprende molto più delle istituzioni ecclesiali dei sinodi diocesani e dei sinodi dei Vescovi, per quanto importanti possano essere tali istituzioni. Non è un caso che Papa Francesco vi abbia fatto riferimento in termini espliciti in un discorso tenuto davanti ai rappresentanti della Chiesa greco-cattolica in Ucraina: “Essere Chiesa è essere comunità che cammina insieme. Non basta avere un sinodo, bisogna essere sinodo. La Chiesa ha bisogno di una intensa condivisione interna: dialogo vivo tra i Pastori e tra i Pastori e i fedeli.”[4] E in occasione della commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi da parte di Papa Paolo VI, Papa Francesco ha espresso la convinzione che seguire e approfondire con determinazione il cammino della sinodalità sia ciò che “Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”, aggiungendo che l’impegno a edificare una Chiesa sinodale è “gravido di implicazioni ecumeniche”[5].
La rivitalizzazione della sinodalità come dimensione essenziale della Chiesa riguarda quindi anche l’ecumenismo come sforzo di ripristinare l’unità della Chiesa. La natura fondamentale di questa interdipendenza tra sinodalità ed ecumenismo è confermata in modo positivo anche da due importanti documenti pubblicati di recente. Qualche anno fa, la Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese ha finalizzato lo studio “La Chiesa verso una visione comune”, che propone una visione multilaterale ed ecumenica della natura, dello scopo e della missione della Chiesa. Questo documento presenta la seguente affermazione ecclesiologica comune: “Tutta la Chiesa è sinodale/conciliare a tutti i livelli della vita ecclesiale – locale, regionale e universale – sotto la guida dello Spirito Santo. Il mistero della vita trinitaria di Dio si riflette nel carattere sinodale o conciliare della Chiesa, e le strutture della Chiesa danno forma a questo carattere per realizzare la vita della comunità come comunità.”[6]
Questo punto di vista è condiviso anche dalla Commissione Teologica Internazionale nel suo documento programmatico “La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa”, dove si constata con gioia che il dialogo ecumenico è progredito sino al punto di riconoscere nella sinodalità una “dimensione rivelatrice della natura della Chiesa”, avvicinandosi alla “concezione della Chiesa come koinonia”, “che si attua in ogni chiesa locale e in relazione alle altre Chiese, attraverso specifiche strutture e processi sinodali”[7].
Tali posizioni incoraggianti dimostrano che è opportuno, nella Chiesa cattolica, inscrivere il concetto di sinodalità, e la discussione intorno ad esso, in una prospettiva ecumenica[8]. Essa è di fondamentale importanza nel processo sinodale che Papa Francesco ha avviato, al livello della Chiesa universale, intorno al tema “Per una Chiesa sinodale. Comunione, partecipazione, missione”, conformemente a quanto affermato nel “Vademecum del Sinodo”: “Il dialogo tra cristiani di diverse confessioni, uniti da un unico battesimo, occupa un posto speciale nel cammino sinodale.”[9] La rilevanza della prospettiva ecumenica è suggerita anche dal fatto che i rappresentanti di altre Chiese cristiane, i cosiddetti “delegati fraterni”, sono stati invitati a partecipare all’assemblea plenaria del Sinodo dei Vescovi, con diritto di parola.
In preparazione al Sinodo dei Vescovi, l’Istituto di Studi Ecumenici della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, con il patrocinio del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e del Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, ha organizzato alcuni Simposi ecumenici internazionali sui concetti e sulle esperienze di sinodalità nelle Chiese cristiane e nelle Comunità ecclesiali dell’Oriente e dell’Occidente con il titolo “Listening to the East” e “Listening to the West” al fine di arricchire il concetto cattolico di sinodalità.[10] I simposi hanno mostrato che la Chiesa cattolica ha molto da imparare dal pensiero teologico e dalle esperienze di altre Chiese nell’edificazione di una Chiesa sinodale. Non solo: essi hanno rivelato altresì che l’approfondimento della dimensione sinodale nella teologia e nella pratica della Chiesa cattolica rappresenta anche un importante contributo che la Chiesa cattolica può apportare ai dialoghi ecumenici, non da ultimo in vista di una comprensione più adeguata della teologia e della pratica del primato nella forma del ministero petrino.
2. Sinodalità ed ecumenismo: un legame essenziale
Facendo un ulteriore passo avanti, sarà opportuno riflettere sullo stretto legame tra sinodalità ed ecumenismo. Di fatti, la sinodalità ha anche una dimensione ecumenica e l’ecumenismo deve essere necessariamente vissuto in modo sinodale. In particolare, occorre approfondire i motivi di questa interconnessione.
a) Camminare insieme
Innanzitutto, sinodalità ed ecumenismo sono inscindibilmente legati all’immagine del cammino. Come abbiamo visto, il termine “sinodalità” contiene la parola stessa di cammino. Sinodalità significa infatti essere in cammino insieme, con il nostro Signore Gesù Cristo. Anche per la comprensione dell’ecumenismo l’idea di cammino è cruciale. L’ecumenismo è il cammino attraverso il quale l’unità della Chiesa, andata persa nella storia a causa delle molteplici divisioni, può essere ripristinata. Non a caso, Papa Giovanni Paolo II ha iniziato il terzo capitolo della sua importante enciclica sull’impegno ecumenico, “Ut unum sint”, con la domanda: “Quanta est nobis via?”: “quanta strada ci separa ancora da quel giorno benedetto in cui sarà raggiunta la piena unità nella fede e potremo concelebrare nella concordia la santa Eucaristica del Signore”?[11].
Papa Francesco pone un accento particolare sulla dimensione di cammino dell’ecumenismo; per lui è fondamentale che i diversi cristiani e le comunità ecclesiali camminino insieme verso l’unità, in modo quindi sinodale, perché l’unità cresce mentre camminiamo e camminare insieme significa già vivere l’unità. Papa Francesco ha espresso dunque la sua convinzione ecumenica con queste parole pregnanti: “L’unità non verrà come un miracolo alla fine: l’unità viene nel cammino, la fa lo Spirito Santo nel cammino.”[12]
Affinché l’unità si realizzi cammin facendo, e quindi in maniera sinodale, tutti i battezzati sono invitati e tenuti a intraprendere questo cammino. L’ecumenismo è infatti un dovere per tutta la Chiesa, come ha sottolineato con forza il Concilio Vaticano Secondo nel decreto sull’ecumenismo “Unitatis redintegratio”: “La cura di ristabilire l’unione riguarda tutta la Chiesa, sia i fedeli che i pastori, e tocca ognuno secondo le proprie possibilità, tanto nella vita cristiana di ogni giorno quanto negli studi teologici e storici.”[13] Occorre quindi fare in modo che tutti i battezzati partecipino all’impegno ecumenico in modo sinodale.
b) Il dialogo come stile di sinodalità ed ecumenismo
Poiché la sinodalità ha il carattere del cammino, Papa Francesco, per rivitalizzarla e approfondirla, non si preoccupa principalmente delle strutture e delle istituzioni ma si concentra sulla sua dimensione interiore e quindi dialogica, in cui il ruolo dello Spirito Santo e il comune ascolto dello Spirito sono cruciali: “Ascoltiamo, discutiamo in gruppo, ma soprattutto prestiamo attenzione a ciò che lo Spirito ha da dirci.”[14]
Alla luce della forte enfasi posta sull’opera dello Spirito Santo e sul comune ascolto di esso, si comprende anche la differenza fondamentale tra sinodalità e parlamentarismo, che Papa Francesco ha più volte evidenziato: mentre il processo democratico serve principalmente a determinare le maggioranze, la sinodalità è un evento spirituale che mira a trovare, sulla via del discernimento spirituale, un’unanimità sostenibile e convincente nella fede e negli stili di vita da essa derivanti del singolo cristiano e della Comunità ecclesiale. Pertanto il sinodo, nelle parole di Papa Francesco, “non è un parlamento, dove per raggiungere un consenso o un accordo comune si ricorre al negoziato, al patteggiamento o ai compromessi, ma l’unico metodo del Sinodo è quello di aprirsi allo Spirito Santo, con coraggio apostolico, con umiltà evangelica e con orazione fiduciosa; affinché sia Lui a guidarci”.[15]
Il vero stile di una Chiesa sinodale è quindi il dialogo. Il principio e il metodo del dialogo non sono semplicemente una moda nella Chiesa di oggi, ma sono suoi elementi intrinsechi, come ha sottolineato Papa Paolo VI nella sua prima enciclica “Ecclesiam suam”: “La Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa parola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si fa colloquio.”[16] Papa Paolo VI ha dunque espresso ciò che il Concilio Vaticano Secondo intendeva: la Chiesa deve essere in dialogo con tutti e quindi vivere sinodalmente.
Come il dialogo è lo stile di una Chiesa veramente sinodale, così anche l’ecumenismo si regge e cade con il suo stile dialogico. Al riguardo, il Decreto sull’ecumenismo “Unitatis redintegratio” afferma che occorrono incontri misti “dove ognuno tratti da pari a pari… quelli che vi partecipano”, ed esprime la necessaria interrelazione che deve esistere in un dialogo veramente ecumenico nella formula: “par cum pari agat”[17]. Da un lato, ciò evidenzia che il dialogo ecumenico si svolge sulla base di un comune patrimonio cristiano ed è quindi un dialogo tra fratelli e sorelle battezzati che ascoltano insieme lo Spirito Santo. Dall’altro, è chiaro anche che il dialogo ecumenico non mette in alcun modo in discussione l’identità di fede dei partner di dialogo, ma piuttosto la presuppone e la apprezza profondamente.
c) Lo scambio dei doni sinodale ed ecumenico
Da ciò emerge il cuore stesso della sinodalità, che si realizza nell’ascolto reciproco e nell’ascolto comune dello Spirito Santo. Il dialogo nello Spirito Santo non è semplicemente uno scambio di idee e di pensieri, ma, in maniera molto più profonda, uno scambio di doni. Per questo, esso apporta un contributo essenziale anche alla riconciliazione ecumenica tra le Chiese cristiane. Anche il dialogo ecumenico avviene come uno scambio di doni, in cui possiamo imparare dagli altri e offrire il nostro contributo. In tale scambio, si tratta soprattutto di accogliere ciò che lo Spirito Santo ha seminato in altre Chiese “come un dono anche per noi”[18]. Questo scambio dialogico si basa sulla convinzione che nessuna Chiesa è così ricca da non aver bisogno di essere arricchita dai doni di altre Chiese, e nessuna Chiesa è così povera da non poter offrire il proprio contributo all’insieme della cristianità.
Come esempio concreto di un simile scambio ecumenico, Papa Francesco accenna al fatto che nel dialogo con i fratelli ortodossi noi cattolici abbiamo l’opportunità “di imparare qualcosa di più sul significato della collegialità episcopale e sulla loro esperienza della sinodalità”[19]. Con ciò arriviamo a uno dei temi centrali del dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse, che da tempo riflette sul rapporto tra sinodalità e primato. Non si tratta affatto di mirare a un compromesso sul minimo comune denominatore. Piuttosto, il punto di forza della Chiesa ortodossa, che è la sinodalità, e il punto di forza della Chiesa cattolica, che è il primato, devono essere messi in dialogo tra loro, nella fiducia che entrambe le parti imparino l’una dall’altra, come ha osservato il gruppo di lavoro cattolico-ortodosso Sant’Ireneo nel suo studio “A servizio della comunità”: “Le Chiese devono soprattutto adoperarsi affinché venga raggiunto un migliore equilibrio tra sinodalità e primato a tutti i livelli della vita ecclesiale, attraverso un rafforzamento delle strutture sinodali nella Chiesa cattolica e attraverso l’accettazione da parte della Chiesa ortodossa di un certo primato all’interno della comunione mondiale delle Chiese.”[20]
3. Principio sinodale e principio gerarchico
Il suddetto rapporto tra sinodalità e primato deve essere approfondito nei dialoghi ecumenici, poiché è percepito e vissuto in modo molto diverso nelle varie Chiese e Comunità ecclesiali. Quanto segue è solo un tentativo di tratteggiare la visione della Chiesa cattolica, visione che deve essere fatta presente nei dialoghi ecumenici.
a) Ricerca di una decisione e presa di decisione
Da una prospettiva cattolica, il concetto e l’edificazione di una Chiesa sinodale non sarebbero intesi correttamente se l’idea di sinodalità fosse contrapposta a quella di gerarchia nella Chiesa. Piuttosto, sinodalità e gerarchia sono strettamente legate, esigendosi e sostenendosi a vicenda. Infatti, senza gerarchia non c’è sinodalità, così come senza sinodalità la gerarchia non può funzionare. Al riguardo, Papa Francesco è convinto che la sinodalità, come “dimensione costitutiva della Chiesa”, offra “la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico”, in quanto coloro che esercitano l’autorità nella Chiesa si chiamano “ministri” “secondo il significato originario della parola”[21]. Papa Francesco ritiene che questo valga anche e precisamente per lo stesso ministero petrino, che potrà ricevere maggiore luce in una Chiesa sinodale: “Il Papa non sta, da solo, al di sopra della Chiesa; ma dentro di essa come Battezzato tra i Battezzati e dentro il Collegio episcopale come Vescovo tra i Vescovi, chiamato al contempo – come Successore dell’apostolo Pietro – a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell’amore tutte le Chiese.”[22]
Il fatto che sinodalità e gerarchia siano inscindibilmente legate è particolarmente evidente se si considera l’etimologia della parola “gerarchia” e se non la si traduce come “santa signoria” ma con “santa origine”[23]. La missione della gerarchia nella Chiesa è dunque quella di proteggere e di tramandare la “santa origine” dell’evento di Cristo, affinché possa compiere la sua opera liberatoria anche nell’attuale situazione della Chiesa. Il ministero gerarchico deve essere rappresentante, garante e guardiano delle verità del Vangelo e della sua non-manipolabilità, facendo in modo che la Chiesa esista a partire da Gesù Cristo come suo capo e che non si dia un proprio ordine e, addirittura, un proprio “vangelo”. Tuttavia, la gerarchia non può svolgere questa missione da sola; piuttosto, è chiamata e tenuta a percorrere questo cammino insieme a tutti i credenti e ai battezzati e quindi in modo sinodale. Per syn-hodos si intende il cammino comune della comunità di fede della Chiesa.
Affinché questa interazione possa funzionare, è necessario tener conto della delicata distinzione tra il processo di ricerca della verità e quello di decisione sulla verità[24]. Se da un lato tutti i credenti devono essere coinvolti, per quanto possibile, nel primo, conformemente al principio già vigente nella Chiesa primitiva per cui ciò che riguarda tutti deve anche avere l’approvazione di tutti[25] − anche il ministero ecclesiale è un membro in ascolto della Chiesa −, dall’altro lato la decisione sulla verità è di competenza del ministero di insegnamento e di guida della Chiesa, e non è delegabile.
Per la comprensione cattolica del concetto di Chiesa è di importanza fondamentale che il principio sinodale e il principio gerarchico interagiscano in modo tale che la vera natura della Chiesa divenga visibile, come afferma il teologo dogmatico gesuita Medard Kehl: “La Chiesa cattolica concepisce se stessa come il ‘sacramento della comunione di Dio’; come tale, è la comunità dei credenti uniti dallo Spirito Santo, conformati al Figlio Gesù Cristo, e chiamati a entrare nel Regno di Dio del Padre insieme a tutta la creazione, una comunità costituita al contempo sinodalmente e ‘gerarchicamente’.”[26]
b) Autorità sinodale, collegiale e personale
In questa definizione, è decisivo il modo in cui viene compreso e attuato questo “al contempo”. Per Papa Francesco, “l’attento esame di come si articolano nella vita della Chiesa il principio della sinodalità ed il servizio di colui che presiede”[27] rappresenta un contributo significativo alla riconciliazione ecumenica tra le Chiese cristiane. Pertanto, il rapporto tra sinodalità e gerarchia deve essere ulteriormente studiato in tutti i dialoghi ecumenici, tanto più che, sul tavolo delle discussioni, la questione del ministero ecclesiale rappresenta il vero e proprio punto cruciale.
Su come intendere il rapporto tra la vita sinodale della Chiesa e il ministero gerarchico, Cipriano di Cartagine, importante vescovo africano della Chiesa primitiva, ha fornito chiare indicazioni, che possono essere feconde anche oggi da un punto di vista ecumenico: “Nihil sine episcopo, nihil sine consilio presbyterii, nihil sine consensu plebis”. Con questa memorabile formula, Cipriano non solo suggerisce che il ministero gerarchico debba realizzarsi e dar prova di sé in tre modi: sinodale, collegiale e personale; egli si rivolge soprattutto contro quei comportamenti che vanno esclusi perché mettono in pericolo la fruttuosa convivenza nella Chiesa.
In primo luogo, sono esclusi i vari tipi di clericalismo, respingendo i quali Cipriano formula il principio sinodale: “nihil sine consensu plebis”. Il ministero nella Chiesa deve essere esercitato e deve rispondere della sua autorità in maniera sinodale. Di fatti, esso è realmente capace di agire solo se è in cammino insieme a tutto il popolo di Dio in una comunione vincolante. La dimensione sinodale trova il suo fondamento evangelico nella convinzione di fede che il popolo santo di Dio partecipi “dell’ufficio profetico di Cristo”, nella promessa che lo Spirito Santo venga effuso a ogni credente e che “la totalità dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo” “non può sbagliarsi nel credere”[28]. Tale sinodalità corrisponde al mistero della Chiesa come “sacramento della comunione di Dio”, in cui tutti i credenti si assumono la responsabilità della vita di fede e dell’edificazione della Chiesa sulla base del sacramento del Battesimo e del sacramento della Cresima.
In secondo luogo, sono escluse le iniziative solitarie di vescovi autocratici, contro le quali Cipriano formula il principio collegiale: “nihil sine consilio presbyterii”. In virtù della sua consacrazione, il vescovo è ammesso al collegio episcopale mondiale, che rappresenta il ministero dei dodici all’interno del popolo di Dio e nel quale il singolo vescovo deve comportarsi in maniera collegiale. Questa dimensione collegiale deve entrare in gioco anche nella chiesa locale affidata al vescovo, specialmente nel rapporto tra vescovo e presbiteri. Il Concilio Vaticano Secondo considera la comunione tra vescovo e presbiteri come “fraternità sacramentale”. La collegialità ha così un fondamento sacramentale, ma deve anche manifestarsi nella vita di tutti i giorni in quanto il vescovo, per la comunione nello stesso sacerdozio e servizio, deve considerare i presbiteri come “fratelli e amici”, e deve essere pronto “ad ascoltarne il parere”, “a consultarlo e a esaminare assieme i problemi riguardanti le necessità del lavoro pastorale e il bene della diocesi”[29].
In terzo luogo, è esclusa la formazione di gruppi separatisti nella Chiesa, contro cui Cipriano richiama il principio personale: “nihil sine episcopo”. Questo principio scaturisce dalla consacrazione e dalla missione conferita al vescovo di annunciare la Parola di Dio, presiedere alle celebrazioni dei sacramenti e governare la Chiesa dietro mandato di Gesù Cristo e nel suo nome. La responsabilità indelegabile del vescovo è quindi quella di rendere visibile e di testimoniare il fatto che la Chiesa esiste in virtù di Cristo e che Egli ne è il capo. Tutta la Chiesa deve riconoscere questa responsabilità personale del vescovo e, di conseguenza, deve rispettare il fatto che il vescovo ha una propria coscienza che non può delegare a nessuno, e che egli deve testimoniare la fede della Chiesa nella sua responsabilità personale. La struttura personale-martirologica del ministero episcopale comporta il fatto che il vescovo, secondo la sua coscienza, è responsabile per la Chiesa locale a lui affidata, come sottolinea con enfasi il canonista Klaus Mörsdorf: “Il vescovo locale e nessun altro, nemmeno un eventuale sistema conciliare, deve garantire che la Chiesa particolare a lui affidata sia in una condizione tale da giustificare il fatto di essere annoverata tra le Chiese particolari in cui consiste e di cui si compone l’unica e sola Chiesa cattolica.”[30]
Niente senza il consenso del popolo di Dio, niente senza il consiglio dei presbiteri e niente senza l’indelegabile responsabilità personale del vescovo. Solo là dove questi tre “nihil sine” sono ugualmente rispettati, e vengono così attuati il principio sinodale, il principio collegiale e il principio personale, la vita ecclesiale conosce una sana armonia e un solido equilibrio. L’esperienza dimostra però che occorrono sforzi continui per conseguire e preservare un tale equilibrio.
Dal punto di vista ecumenico, può essere utile tornare con il pensiero al Concilio degli apostoli di Gerusalemme, che è stato giustamente visto nel corso della storia come l’archetipo paradigmatico delle assemblee sinodali. In merito a questo Concilio degli apostoli ci viene tramandato che, dopo dettagliate discussioni nella comunità di Gerusalemme e dopo aver accettato l’autorevole testimonianza e il credo di Pietro, la decisione fu presa da Giacomo, capo della Chiesa di Gerusalemme, in questi termini: “È stato deciso, dallo Spirito Santo e noi” (At 15,28). La questione importante fu decisa da Giacomo per la forza dell’azione dello Spirito Santo; poi tale decisione fu accettata da tutta l’assemblea di Gerusalemme e in seguito anche da quella di Antiochia. Con questa netta distinzione tra la ricerca di una decisione, a cui deve partecipare tutta la comunità, e la presa di decisione che spetta all’autorità ecclesiastica, l’evento del Concilio apostolico mostra chiaramente ancora una volta che sinodalità e gerarchia sono interdipendenti e devono rapportarsi l’una con l’altra.
4. L’approfondimento spirituale della sinodalità
Torniamo dunque alla dimensione spirituale della sinodalità, che è essenziale per la sua credibile realizzazione. Dobbiamo partire dall’osservazione storica che la Chiesa nascente si è data il nome di “ekklesia”[31], accanto alla sinagoga ebraica. Nella terminologia greca profana, questa parola si riferiva all’assemblea popolare di una comunità politica; nel linguaggio della fede, invece, indica la comunità dei credenti riuniti. Quest’ultima comunità differisce dalla prima principalmente per il fatto che, nella polis greca, gli uomini si radunavano per prendere decisioni importanti, mentre la comunità di fede si riuniva come “ekklesia” non per decidere da sé, ma per ascoltare ciò che Dio aveva deciso, per dare a ciò il proprio consenso e per tradurlo nella quotidianità.
Anche sulla base di tale concetto si capisce perché la parola “ekklesia” indichi il culto cristiano e quindi il raduno della comunità di fede convocata per l’Eucaristia. L’essenza più profonda della Chiesa come “ekklesia” e “sinodo” è l’assemblea eucaristica. La Chiesa quale sinodo vive soprattutto là dove i cristiani si radunano per celebrare l’Eucaristia, come giustamente sottolinea la Commissione Teologica Internazionale: “Il cammino sinodale della Chiesa è configurato e alimentato dall’Eucaristia.”[32] Il fatto che l’origine e il culmine della sinodalità risiedano nella partecipazione consapevole e attiva dei credenti all’assemblea eucaristica trova ancora oggi espressione nell’usanza di dare inizio alle assemblee sinodali, come i concili o i sinodi dei Vescovi, con la celebrazione dell’Eucaristia e con l’intronizzazione del Vangelo, come già prescritto a partire dai Concili di Toledo nel VII secolo fino al Ceremoniale Episcoporum del 1984.
Poiché la sinodalità della Chiesa necessita sempre di un approfondimento spirituale, essa può imparare molto dal movimento ecumenico anche sotto questo aspetto. Ci riferiamo qui, in particolare, all’ecumenismo spirituale, che il Decreto sull’ecumenismo del Concilio Vaticano Secondo definisce “l’anima di tutto il movimento ecumenico”[33]. Esso trova infatti il suo fondamento nella preghiera sacerdotale del Signore, che pregò per l’unità dei suoi discepoli prima della sua passione.[34] Su questo fondamento, la preghiera per l’unità dei cristiani è la forma essenziale di ecumenismo a cui tutti i battezzati possono partecipare in modo sinodale. Pregando per l’unità, noi cristiani esprimiamo la nostra convinzione di fede secondo cui noi esseri umani non possiamo fare da soli l’unità, né possiamo determinarne la forma e i tempi. Noi esseri umani possiamo produrre divisione, come dimostra la storia e purtroppo anche il presente. L’unità, invece, la possiamo solo ricevere in dono dallo Spirito Santo, che è la fonte e la forza motrice divina dell’unità della Chiesa.
5. Il Grande Giubileo della sinodalità
Le riflessioni sull’interdipendenza tra sinodalità ed ecumenismo ci portano infine a ricordare che l’intera cristianità si sta avvicinando a un anniversario molto significativo della sinodalità vissuta e praticata, che verrà celebrato il prossimo anno, ovvero il 1700° anniversario del primo Concilio ecumenico della storia della Chiesa, svoltosi a Nicea nel 325. Dal punto di vista del rapporto tra sinodalità ed ecumenismo, questo evento è di grande rilievo soprattutto per due aspetti.[35]
Innanzitutto, va tenuto presente che nella cristianità dell’epoca si era accesa una feroce disputa su come il credo della Chiesa che professava Gesù Cristo come Figlio di Dio potesse essere conciliato con la fede altrettanto cristiana in un unico Dio. Il teologo alessandrino Ario, in particolare, sosteneva il modello di un monoteismo strettamente filosofico, secondo il quale Cristo poteva essere considerato “Figlio di Dio” solo in senso improprio. Poiché l’imperatore Costantino vedeva in questa disputa una grave minaccia al suo progetto di consolidare l’unità dell’impero sul fondamento dell’unità della fede cristiana, egli decise di convocare il primo Concilio ecumenico nella città di Nicea, in Asia Minore, vicino alla metropoli di Costantinopoli, da lui fondata. Questo Concilio definì eretici gli insegnamenti di Ario e li respinse, confermando invece la professione di fede secondo cui Gesù Cristo, in quanto Figlio di Dio, è “consustanziale” al Padre.
Questa confessione è diventata la base della fede cristiana comune, soprattutto perché il Concilio di Nicea ebbe luogo in un’epoca in cui il mondo cristiano non era ancora stato lacerato dalle numerose divisioni successive. Il credo cristologico del Concilio unisce ancora oggi tutte le Chiese e le Comunità ecclesiali cristiane e la sua importanza ecumenica non va quindi sottovalutata. Il ripristino ecumenico dell’unità della Chiesa, infatti, presuppone un accordo sul contenuto fondamentale della fede, non solo tra le Chiese e le Comunità ecclesiali di oggi, ma anche tra la Chiesa di oggi e la Chiesa del passato e, soprattutto, la sua origine apostolica.
In secondo luogo, il Concilio ecumenico di Nicea è di grande importanza perché riuscì a dirimere l’accesa polemica sulla professione di fede cristologica e a definire anche altre questioni pastorali e disciplinari, come la diversa datazione della Pasqua, problema esistente già all’epoca. A questo proposito, il Concilio testimonia anche il modo in cui le questioni controverse della fede e della disciplina ecclesiastica venivano discusse e decise sinodalmente in un Concilio, soprattutto se si considera che il Concilio riuniva i primi servitori di Dio “di tutte le Chiese di tutta l’Europa, dell’Africa e dell’Asia”, come riferisce lo storico della Chiesa Eusebio di Cesarea, che fu egli stesso un padre conciliare e vide il Concilio di Nicea come una nuova Pentecoste[36]. È quindi giusto considerare il Concilio di Nicea come l’inizio della modalità sinodale della ricerca di una decisione e della presa di una decisione nella Chiesa universale.
Per queste due ragioni è auspicabile che il 1700° anniversario del primo Concilio ecumenico di Nicea venga percepito non solo come un’occasione propizia per commemorare questo Concilio in una comunione ecumenica e per riaffermare il suo credo cristologico, ma anche come un invito a trarre un’importante lezione dalla storia e ad approfondire oggi il pensiero sinodale in uno spirito ecumenico, ancorandolo alla vita ecclesiale. Non solo l’ecumenismo deve essere portato avanti in maniera congiunta e, quindi, sinodale per poter avanzare sulla via della ricomposizione dell’unità della Chiesa, ma anche lo sforzo di rinvigorire la sinodalità nella vita della Chiesa può imparare molto dal movimento ecumenico e dalla sua pratica sinodale. Preghiamo lo Spirito Santo affinché l’interdipendenza tra sinodalità ed ecumenismo si riveli fruttuosa anche nel Sinodo dei Vescovi e nel suo impegno a edificare una Chiesa sinodale.
[1] Francesco, Discorso a Sua Santità Mar Awa III, Cathaolicos-Patriarca della Chiesa assira dell’Oriente, il 19 novembre 2022.
[2] J. Cardinal Ratzinger, Weggemeinschaft des Glaubens. Kirche als Communio (Augsburg 2002).
[3] J. Chrysostomos, Exlicatio in Ps 149, in: PG 55, 493.
[4] Francesco, Discorso ai Presuli della Chiesa greco-cattolica ucraina, il 5 luglio 2019.
[5] Francesco, Discorso per la commemorazione del 50.mo anniversario del Sinodo dei Vescovi, il 17 ottobre 2015.
[6] Die Kirche auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision. Eine Studie der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) (Gütersloh – Paderborn 2015).
[7] Internationale Theologische Kommission, Die Synodalität in Leben und Sendung der Kirche, Nr. 116.
[8] Vgl. K. Kardinal Koch, Synodalität in der Katholischen Kirche in ökumenischer Perspektive: Papst und Bischöfe, Konzilien und Synoden, in: M. Graulich, J. Rahner (Hrsg.), Synodalität in der katholischen Kirche. Die Studie der Internationalen Theologischen Kommission im Diskurs (Freiburg i. Br. 2020) 220-242.
[9] Vademecum del Sinodo, n. 5.3.7.
[10] Listening to the East. Synodality in Eastern and Oriental Orthodox Church Traditions. Ed. by Institute for Ecumenical Studies of the Angelicum, Pro Oriente Foundation = Collana Ut Unum Sint / 4 (Città del Vaticano 2023).
[11] Giovanni Paolo II, Ut unum sint, n. 77.
[12] Francesco, Omelia durante la celebrazione dei Vespri nella Solennità della Conversione di San Paolo Apostolo, il 25 gennaio 2014.
[13] Unitatis redintegratio, n. 5.
[14] Franziskus, Wege zu träumen. Mit Zuversicht aus der Krise. Im Gespräch mit Austen Ivereigh (München 2020) 111.
[15] Francesco, Introduzione al Sinodo per la famiglia, il 5 ottobre 2015.
[16] Paolo VI, Ecclesiam suam, n. 65.
[17] Unitatis redintegratio, n. 9.
[18] Francesco, Evangelii gaudium, n. 246.
[19] Ibid.
[20] Im Dienst an der Gemeinschaft. Das Verhältnis von Primat und Synodalität neu denken. Eine Studie des Gemeinsamen orthodox-katholischen Arbeitskreises St. Irenäus (Paderborn 2018) 94.
[21] Francesco, Discorso per la Commemorazione del 50.mo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, il 17 ottobre 2015.
[22] Ibid.
[23] L. Scheffczyk, Das Petrusamt in der Kirche: Übergeordnet – eingefügt, in: A. Brandenburg / H. J. Urban (Hrsg.), Petrus und Papst. Evangelium – Einheit der Kirche – Papstdienst. Band II: Neue Beiträge (Münster 1978) 142-158, bes. 146.
[24] A proposito di questa importante distinzione cfr. H. J. Pottmeyer, Wahrheit „von unten“ oder „Wahrheit von oben“? Zum verantwortlichen Umgang mit lehramtlichen Aussagen, in: U. Struppe und J. Weismayer (Hrsg.), Öffnung zum Heute. Die Kirche nach dem Konzil (Innsbruck-Wien 1991) 13-30.
[25] Vgl. Y. Congar, Quod omnes tangit, ab omnibus tractari debet, in: Revue historique et droit francais et étranger 36 (1958) 210-259.
[26] M. Kehl, Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie (Würzburg 1992) 51.
[27] Francesco, Discorso alla Delegazione ecumenica del Patriarcato di Costantinopoli, il 27 giugno 2015.
[28] Lumen gentium, n. 12.
[29] Presbyterorum ordinis, n. 7.
[30] K. Mörsdorf, Die Rolle des Ortsbischofs in dem Zuordnungsverhältnis von Gesamtkirche und Teilkirche, in: H. Fleckenstein, G. Gruber, G. Schwaiger, E. Tewes (Hrsg.), Ortskirche – Weltkirche. Festgabe für Julius Kardinal Döpfner (Würzburg 1973) 439-458, zit. 450.
[31] Vgl. R. Pesch, Gott ist gegenwärtig. Die Versammlung des Volkes Gottes in Synagoge und Kirche (Augsburg 2006).
Internationale Theologische Kommission, Die Synodalität in Leben und Sendung der Kirche, Nr. 47.
[33] Unitatis redintegratio, n. 8.
[34] Vgl. K. Kardinal Koch, Christliche Ökumene im Licht des Betens Jesu. „Jesus von Nazareth“ und die ökumenische Sendung, in: J-H. Tück (Hrsg.), Passion aus Liebe. Das Jesus-Buch des Papstes in der Diskussion (Ostfildern 2011) 19-36.
[35] Vgl. K. Kardinal Koch, Auf dem Weg zu einer ökumenischen Feier des 1700. Jahrestags des Konzils von Nicaea (325-20025), in. P. Knauer, A. Riedl, D. W. Winkler (Hrsg.), Patrologie und Ökumene. Theresia Hainthaler zum 75. Geburtstag (Freiburg i. Br. 2022) 320-341.
[36] Eusebius, Vita Const. III. 7.