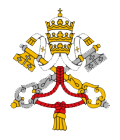L’ecumenismo – “gioia inaspettata” del Sinodo
Mons. Juan Usma Gómez
Capo della Sezione occidentale
Rev.do P. Hyacinthe Destivelle, OP
Officiale della Sezione orientale
Un’icona mariana slava del XIX secolo si intitola “Gioia inaspettata”. Essa mostra la gioiosa sorpresa del convertito per il perdono ricevuto. Questa gioia inattesa potrebbe essere percepita di fronte alle promesse ecumeniche del recente Sinodo sulla sinodalità. Mentre si aspettavano decisioni sul governo, sui ministeri o sulla disciplina della Chiesa, è probabilmente in ambito ecumenico che i frutti del Sinodo saranno più palpabili.
Non sembra esagerato il parallelo con il Concilio Vaticano II, che ha aperto una nuova pagina nella storia delle relazioni della Chiesa cattolica con gli altri cristiani. Invitando per la prima volta osservatori di altre comunità cristiane, la Chiesa cattolica aveva voluto coinvolgere l'intero mondo cristiano nella sua riflessione e nel suo aggiornamento. Infatti, la loro semplice presenza influenzò notevolmente i lavori e i documenti conciliari, e permise l'avvio di dialoghi teologici all'indomani del Concilio.
Sessant'anni dopo, il sinodo sulla sinodalità potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nelle relazioni ecumeniche della Chiesa cattolica. I sedici “delegati fraterni” non erano semplici osservatori, ma partecipanti a pieno titolo alla riflessione sinodale, abilitati a intervenire sia nei circuli minores che nell'assemblea plenaria, e addirittura a proporre emendamenti al testo finale. Alla luce della veglia ecumenica di preghiera “Together” per affidare i lavori sinodali allo Spirito Santo, l’Assemblea non ha esitato ad affermare che “ci troviamo in un kairos ecumenico” (Relazione di sintesi, 2023, 7.a), che “il cammino sinodale ci orienta così verso una piena e visibile unità dei cristiani” (Documento finale, n. 4) e che lo slancio ecumenico è stato uno “tra i frutti più significativi del Sinodo 2021-2024” (id., n. 137).
Questa dimensione ecumenica è illustrata da numerosi passaggi del Documento finale dedicati all'unità, in particolare alla dimensione battesimale dell'ecumenismo e della sinodalità, all'ecumenismo spirituale, all'ecumenismo del sangue, alla necessità di ricevere i frutti del dialogo, allo scambio dei doni, ai rapporti tra sinodalità e primato, al contributo dei delegati fraterni e alla dimensione ecumenica della formazione.
Esiste infatti un triplice rapporto tra sinodalità ed ecumenismo. Da un lato, la sinodalità interna alla Chiesa cattolica è un elemento fondamentale per tutte le sue relazioni ecumeniche e dall’altro una sinodalità ad extra viene vissuta nel contesto degli incontri tra cristiani. Come ha dichiarato il Santo Padre nel 2022 ricevendo il Patriarca della Chiesa assira d'Oriente: “Il cammino della sinodalità, che la Chiesa cattolica sta percorrendo, è e deve essere ecumenico, così come il cammino ecumenico è sinodale”. A queste due dimensioni se ne aggiunge una terza: la Chiesa cattolica può imparare dalle altre Chiese la sinodalità stessa.
La portata ecumenica della sinodalità ad intra
Il Sinodo ha riaffermato che la sinodalità è la pietra di paragone dell'impegno ecumenico della Chiesa cattolica. Come già sottolineato dall'Instrumentum Laboris nel 2023: “vi è una relazione reciproca tra l’ordinamento sinodale della Chiesa cattolica e la credibilità del suo impegno ecumenico” (B.1.4.e). La Chiesa cattolica deve mostrare ai suoi interlocutori un modello sinodale convincente a tutti i livelli.
I nostri partner ecumenici saranno particolarmente attenti alla dimensione regionale della sinodalità. Secondo il parallelo stabilito dalla Lumen Gentium 23 tra conferenze episcopali e patriarcati, già nel 1969 l’allora Professore Ratzinger si chiedeva “se le Chiese dell'Asia e dell'Africa, come quelle dell'Oriente, non potessero ‘diventare l'equivalente’ di patriarcati sotto questo o un altro nome” (Das neue Volk Gottes, 142). A tale proposito, il Documento finale del Sinodo afferma che nel processo sinodale, le Assemblee ecclesiali continentali costituiscono un patrimonio da valorizzare come mezzo efficace per attuare l'insegnamento del Concilio: “Occorrerà chiarirne meglio lo statuto teologico e canonico, così come quello dei raggruppamenti continentali di Conferenze episcopali, per poter metterne a frutto le potenzialità per l’ulteriore sviluppo di una Chiesa sinodale” (n. 126).
A livello universale, l’attuale prassi del Sinodo, che articola “il coinvolgimento di tutti (il santo Popolo di Dio), il ministero di alcuni (il Collegio dei Vescovi) e la presidenza di uno (il Successore di Pietro)” (n. 136), rinnova profondamente l'esercizio del primato, in linea con quanto affermato nel 2018 dalla costituzione Episcopalis communio: “l’attività del Sinodo dei Vescovi potrà a suo modo contribuire al ristabilimento dell’unità fra tutti i cristiani, secondo la volontà del Signore (cfr. Gv 17, 21). Così facendo esso aiuterà la Chiesa cattolica, secondo l’auspicio formulato anni orsono da Giovanni Paolo II, a ‘trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova’ (UUS 95)” (n. 10).
La risposta all'appello di Ut unum sint, come afferma il Documento finale, “è una sfida fondamentale sia per una Chiesa sinodale missionaria sia per l’unità dei cristiani” (n. 137). A questo proposito, il documento loda la recente pubblicazione del documento Il Vescovo di Roma, che mostra come la promozione dell'unità dei cristiani sia un aspetto essenziale del ministero del Vescovo di Roma e come il cammino ecumenico abbia favorito una migliore comprensione di tale ministero. Il Sinodo invita ad approfondire le proposte concrete contenute in questo documento del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani, in particolare un commento ufficiale delle definizioni dogmatiche del Concilio Vaticano I e una più chiara distinzione tra le diverse responsabilità del Papa – in primo luogo tra il suo ruolo patriarcale nella Chiesa latina e il suo ruolo primaziale al servizio della comunione delle Chiese.
Sinodalità ad extra
Una sinodalità meglio vissuta nella Chiesa cattolica è quindi un elemento fondamentale per tutte le sue relazioni ecumeniche. Esiste un’ulteriore dimensione ecumenica della sinodalità, quando essa si realizza concretamente nel quadro degli incontri tra cristiani. Potremmo qualificare questa forma di sinodalità come “sinodalità ad extra”. Sebbene la sinodalità sia una realtà interna alle Chiese, il concetto può essere applicato anche ai rapporti tra di loro, poiché anche il cammino ecumenico è un processo del “camminare insieme”. Come affermato nell’Instrumentum Laboris del 2023: “una certa sinodalità tra le Chiese si sperimenta ogni volta che cristiani di diverse tradizioni si riuniscono nel nome di Gesù Cristo per la preghiera, l’azione e la testimonianza comuni, nonché per le consultazioni regolari e la partecipazione ai rispettivi processi sinodali” (B.1.4.f).
Questa sinodalità ad extra esiste già. Particolarmente importante è l’invito rivolto alle altre comunioni cristiane a partecipare ai processi sinodali cattolici a tutti i livelli. A livello universale, recenti iniziative, come l’incontro del 2018 a Bari dei Capi di Chiesa del Medio Oriente, o la veglia ecumenica di preghiera “Together” nel 2023, illustrano questo tipo di sinodalità. Il Documento finale del Sinodo invita “a immaginare pratiche sinodali ecumeniche, fino a forme di consultazione e discernimento su questioni di interesse condiviso e urgente, come potrebbe essere la celebrazione di un Sinodo ecumenico sull’evangelizzazione” (n. 138) e di “mettere in pratica forme di sinodalità tra cristiani di tutte le tradizioni” (n. 139), in particolare in occasione della preparazione e celebrazione del 1700° anniversario del Concilio di Nicea.
Un ultimo aspetto di questa sinodalità ad extra è la “mutual accountability” tra i cristiani. Ciò che facciamo e decidiamo, infatti, ha importanti ripercussioni sulla vita degli altri cristiani. Il Documento finale sottolinea che il cammino ecumenico invita anche “a rendere conto reciprocamente di ciò che siamo, di ciò che facciamo e di ciò che insegniamo” (n. 138). Un esempio recente delle implicazioni ecumeniche di un documento apparentemente interno alla Chiesa cattolica sono state le reazioni alla dichiarazione Fiducia Supplicans da parte di altre comunità cristiane.
La sinodalità come ascolto degli altri cristiani
Menzioniamo una terza dimensione del rapporto tra sinodalità ed ecumenismo: la sinodalità come ascolto degli altri cristiani. Infatti, se una Chiesa sinodale si caratterizza per “un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare” (Francesco, Discorso in occasione della commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi, 17 ottobre 2015), tale ascolto non riguarda solo i cattolici, ma tutti i battezzati.
Il motivo principale per invitare rappresentanti di altre Chiese e Comunioni cristiane ai processi sinodali della Chiesa cattolica è che tutti i battezzati partecipano al sensus fidei. Come affermato nel Documento finale dell’Assemblea sinodale del 2024: “Attraverso il battesimo tutti i cristiani partecipano al sensus fidei. Perciò esso, oltre che principio della sinodalità, costituisce anche il fondamento dell’ecumenismo” (n. 23). Non si tratta di ascoltare solo esperti teologi o pastori di altre Chiese, ma l'istinto di fede insito in tutti i cristiani in virtù del loro battesimo. A questo proposito, il Sinodo ha confermato il comune fondamento battesimale sia della sinodalità che dell'ecumenismo, entrambi i quali rimandano a un'ecclesiologia battesimale.
L'ascolto degli altri cristiani appare particolarmente importante se intendiamo il cammino ecumenico come “scambio di doni”, secondo l'espressione spesso usata da Giovanni Paolo II. Il Documento finale del Sinodo sottolinea che “lo scambio dei doni ha un significato cruciale anche nel cammino verso la piena e visibile unità” (n. 122). I cattolici possono imparare dagli altri cristiani sulla sinodalità stessa: “la ricchezza rappresentata dalla partecipazione all’Assemblea sinodale dei Delegati fraterni, provenienti da altre Chiese e Comunioni cristiane, ci invita a prestare più attenzione alle pratiche sinodali dei nostri partner ecumenici, sia in Oriente sia in Occidente” (n. 138). Infatti, “il dialogo ecumenico è fondamentale per sviluppare la comprensione della sinodalità e dell’unità della Chiesa” (id.). I cattolici possono trarre ispirazione anche dall’esperienza sinodale del Movimento ecumenico in quanto tale. Particolarmente degne di nota, ad esempio, sono le procedure del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che permettono di raggiungere un consenso senza ricorrere al voto. Come si legge nell’Instrumentum Laboris del 2023: “il movimento ecumenico è un laboratorio di sinodalità, in particolare potrebbe essere fonte di ispirazione la metodologia del dialogo e della ricerca del consenso sperimentata a vari livelli al suo interno” (B.1.4.c).
Lo scambio dei doni, infine, risulta particolarmente convincente riguardo all’“ecumenismo dei santi”: “Anche l’esempio dei santi e testimoni della fede di altre Chiese e Comunioni cristiane è un dono che possiamo ricevere, inserendo la loro memoria nel nostro calendario liturgico, in particolare per i martiri” (n. 122). L'inserimento nel Martirologio Romano dei 21 martiri copti nel 2023, come quello di Isacco di Ninive nel 2024, pochi giorni dopo il Sinodo, illustra questo scambio di doni che manifesta e approfondisce la comunione già esistente tra i cristiani.
Abbiamo individuato tre aspetti ecumenici della sinodalità: in primo luogo, la sinodalità ad intra nella Chiesa cattolica è fondamentale per le sue relazioni ecumeniche; in secondo luogo, una sinodalità ad extra può essere un mezzo privilegiato sul cammino dei cristiani verso la piena comunione; in terzo luogo la Chiesa cattolica può imparare dalla sinodalità delle altre tradizioni cristiane. In questo senso, la sinodalità non solo è importante per l’ecumenismo, ma è anche un frutto dell'impegno ecumenico della Chiesa cattolica.
Queste rinnovate convinzioni e proposte ecumeniche forse non erano l’obiettivo primario del Sinodo. Tuttavia, esse potrebbero esserne uno dei frutti più tangibili, una “gioia inaspettata” – per riprendere il titolo dell’icona sopramenzionata – sul “cammino comune” caratteristico della sinodalità come pure dell’ecumenismo. Su questo cammino, come accenna il Sinodo nella sua conclusione (n. 155), vi è un'altra icona mariana bizantina, l’“Odigitria”, colei che “indica la via” e guida la comunità nascente ad aprirsi alla novità della Pentecoste.
L'Osservatore Romano, 20 gennaio 2025