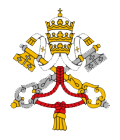Giovanni Paolo II e l’Europa
Conferenza presso Carità Politica
Roma, 15 ottobre 2025
La Chiesa cattolica si concepisce come una comunità di fede mondiale, la cui universalità emerge fin dal momento in cui è nata, nella prima Pentecoste. Ma l’Europa, rispetto agli altri continenti, svolge un ruolo centrale nel pensiero e nel magistero dei papi che guidano la Chiesa universale, e non solo nel caso dei pontefici europei, ma anche nel caso di Papa Francesco, il primo papa proveniente dall'America Latina, il quale ha avuto antenati, a dire il vero, che emigrarono dall’Italia in Argentina. L'attenzione all’Europa è certamente legata anche al fatto che il fulcro spirituale della Chiesa universale si trova in Vaticano e quindi in Europa.
La grande importanza dell’Europa è particolarmente evidente nel pensiero e nell’opera di Papa Giovanni Paolo II, giunto a Roma dall’ex blocco dell’Europa dell’est. Egli sarà certamente ricordato come il papa che pronunciò il maggior numero di discorsi e di esortazioni sull'Europa e che dedicò molti viaggi apostolici ai paesi europei. Soprattutto in vista della Costituzione europea che si stava delineando in quel momento, si impegnò a fondo affinché nel testo fossero menzionate e dunque riconosciute le radici cristiane dell’Europa. Fu il primo Papa a visitare, l’11 ottobre 1988, il Parlamento europeo a Strasburgo, dove pronunciò un discorso memorabile, offrendo forti impulsi spirituali, etici e politici. Nel 1991 e nel 1999 convocò e presiedette due Assemblee Speciali del Sinodo dei Vescovi sull’Europa in preparazione all’Anno Santo 2000. Nel 2003 pubblicò l’esortazione apostolica postsinodale “Ecclesia in Europa” e nel 1983 l’enciclica “Slavorum Apostoli”. A Benedetto da Norcia, proclamato Patrono d’Europa da Papa Paolo VI, affiancò i due apostoli slavi Cirillo e Metodio e tre sante, Brigida di Svezia, Caterina da Siena e Teresa Benedetta della Croce, come Patroni d’Europa. In riconoscimento dei suoi tanti meriti, e in particolare del suo straordinario lavoro a favore dell’unità dell’Europa, della salvaguardia dei valori europei e del suo messaggio di pace, venne conferito a Papa Giovanni II, il 24 marzo 2004 ad Aquisgrana, il Premio Internazionale Carlo Magno.
1. L’Europa come frutto dell’evangelizzazione
Questi brevi accenni indicano anche quali sono i tratti principali del pensiero di Papa Giovanni Paolo II in merito all’Europa. Emerge innanzitutto che, per il Papa, l’Europa è più di un luogo geografico; essa è “un concetto prevalentemente culturale e storico, che caratterizza una realtà nata come Continente grazie anche alla forza unificante del cristianesimo, il quale ha saputo integrare tra loro popoli e culture diverse ed è intimamente legato all’intera cultura europea”[1]. La fede cristiana rappresenta dunque un elemento importante dell’identità culturale dell’Europa, che sarebbe incomprensibile senza il cristianesimo e che deve essere considerata frutto dell’evangelizzazione. Papa Giovanni Paolo II condensò questo aspetto significativo in un’unica frase: “L’Europa è stata battezzata dal cristianesimo”[2].
Per Giovanni Paolo II, il ruolo primario dell’Europa nell’evangelizzazione era già evidente agli albori del cristianesimo, come si legge negli Atti degli Apostoli: mentre stava ancora annunciando il Vangelo in Asia Minore, San Paolo fu misteriosamente chiamato ad attraversare il confine tra i due continenti (cfr. Atti 16,9). Successivamente, gli apostoli, in particolare Pietro e Paolo, portarono il Vangelo di Gesù Cristo in Grecia e a Roma. In seguito, l’evangelizzazione ebbe i suoi due poli principali a Roma e a Bisanzio. Questo fatto storico spiega il motivo per cui Papa Giovanni Paolo II sottolineò costantemente che l’Europa avrebbe potuto avere un futuro positivo solo se avesse imparato a respirare con entrambi i polmoni, quello romano-occidentale e quello bizantino-orientale. Si tratta di un’immagine potente: proprio come un organismo umano sano ha bisogno di due polmoni, così anche la Chiesa, che è anch’essa, a livello spirituale, un organismo, ha bisogno delle due tradizioni “per poter attingere in modo più completo ai tesori della Rivelazione”[3]. Per aggiungere forza a questo impulso, il Papa dichiarò anche i due apostoli slavi Cirillo e Metodio Patroni d’Europa. Mentre l’obiettivo principale di San Benedetto era “unire la romanità al Vangelo”[4], i santi Cirillo e Metodio operarono coraggiosamente un’inculturazione del messaggio evangelico nella cultura slava, accogliendo anche la lingua, i costumi e lo spirito di questa tradizione.
Per Papa Giovanni Paolo II, erano soprattutto i santi, con il loro convincente esempio di vita ispirata alle Beatitudini di Gesù nel Vangelo, i protagonisti più credibili della missione della Chiesa in Europa. Ciò vale in particolare per le sante che hanno svolto un ruolo cruciale nella storia della Chiesa e nelle società del continente europeo. Per rendere omaggio all’importante missione delle donne, Papa Giovanni Paolo II, alle soglie del Giubileo dell’Anno 2000, affiancò ai tre grandi co-patroni europei tre nuove sante, particolarmente significative per il continente europeo: Santa Caterina da Siena, umile e coraggiosa terziaria domenicana, che, nel XIV secolo, portò la pace a Siena, all’Italia e all’Europa e favorì persino il ritorno del Papa da Avignone a Roma; Santa Brigida di Svezia che, sempre nel XIV secolo, percorse l’Europa da nord a sud e si adoperò instancabilmente per l’unità dei cristiani; Edith Stein che, di famiglia ebrea ma divenuta più tardi carmelitana, fu uccisa dai nazisti nel campo di concentramento di Auschwitz, diventando così “simbolo dei drammi dell’Europa di questo secolo”[5].
2. L’identità cristiana dell’Europa
La vita dei santi è la prova più chiara dei frutti dell’evangelizzazione cristiana nelle società del continente europeo. Poiché Papa Giovanni Paolo II riteneva che fosse l’evangelizzazione ad aver plasmato l’Europa e ad aver fornito l’impulso fondamentale per la civilizzazione dei suoi popoli e delle sue culture, viene spontaneo chiedersi come egli percepiva l’identità cristiana del continente europeo. Egli era certo che l’Europa potesse edificare un’unità vera e feconda solo se costruita sulle sue basi spirituali.
Ciò significa, innanzitutto, che l’Europa ha bisogno di una dimensione religiosa e, soprattutto, che deve riconoscere la qualità trascendente fondamentale della vita umana. L’Europa sta in piedi o cade con una “visione teocentrica della realtà”, contemporaneamente “cosmologica” e “antropologica”[6]. Papa Giovanni Paolo II era convinto che questa visione teocentrica si realizzasse più chiaramente nella fede cristiana. Infatti, nella vicenda umana di Gesù di Nazaret, “il Trascendente è entrato nella storia, l’Eterno nel tempo, l’Assoluto nella precarietà della condizione umana”[7]. La Chiesa cristiana deve quindi proclamare sempre questo messaggio: Cristo è la fonte di speranza per l’Europa e per il mondo intero.
L’identità cristiana dell'Europa, desiderosa di preservare l’unità della sua anima, comprende anche la salvaguardia e l’affermazione di quei valori umani e cristiani ai quali il cristianesimo ha apportato un contributo decisivo nel corso della sua storia evangelizzatrice. Tra questi rientrano la decisa promozione e tutela della dignità trascendente della persona umana dalla sua nascita alla sua morte naturale e i conseguenti valori della ragione, della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e della distinzione tra politica e religione.
È soprattutto nel suo celebre discorso tenuto davanti al Parlamento Europeo l’11 ottobre 1988 a Strasburgo che Papa Giovanni Paolo II pose un’enfasi particolare sul valore della distinzione essenziale tra religione e politica, che egli vedeva fondato nelle parole di Gesù: “Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” (Mt 22,21). Da un lato, era normale per il Papa che la Chiesa cattolica non mirasse al ritorno ad alcuna forma di Stato confessionale nei suoi rapporti con gli Stati. Dall’altro, egli rifiutava un laicismo ideologico che escludesse Dio dalla vita pubblica e quindi stabilisse una separazione tra istituzioni statali e comunità religiose. Rispetto a queste due posizioni estreme, la Chiesa cattolica è disposta a lavorare insieme agli Stati, convinta di poter apportare elementi importanti alla necessaria unificazione dell’Europa. Tra questi, vi è soprattutto la visione di un’unità essenziale nella diversità delle espressioni culturali, la consapevolezza di appartenere a una comunità mondiale radicata nelle diverse comunità locali e, quindi, il senso di ciò che unisce, trascendendo ciò che divide.
Riflettendo sulla grande eredità cristiana nella cultura europea, Papa Giovanni Paolo II era anche consapevole del fatto che l’Illuminismo, tra il XVII e il XVIII secolo, prima in Francia, poi in Inghilterra e in Germania, aveva rimesso radicalmente in discussione il carattere cristiano dell’Europa: “L’Illuminismo, nelle sue varie espressioni, si oppose a ciò che l’Europa era diventata a seguito dell’evangelizzazione”[8]. D’altro canto, il Papa riconosceva che l’Illuminismo europeo aveva prodotto anche frutti positivi, come le idee di libertà, uguaglianza e fraternità, che a loro volta affondavano le radici nel Vangelo. Soprattutto, egli riteneva che l’Illuminismo europeo avesse preparato il terreno a una migliore comprensione dei diritti umani, il cui fondamento imprescindibile consisteva, a suo parere, nel diritto alla libertà religiosa. E nei documenti del Concilio Vaticano II, il Papa individuò persino una “sintesi stimolante del rapporto tra cristianesimo e Illuminismo”[9]. In questo senso, egli ravvisò anche nella storia moderna dell’Europa importanti dimensioni dell’eredità cristiana.
3. Gli sforzi compiuti per ritrovare l’unità perduta in Europa
Guardando ai secoli passati, Papa Giovanni Paolo II giunse alla convinzione che il cristianesimo potesse agire sul continente europeo come “fattore primario di unità tra i popoli e le culture e di promozione integrale dell’uomo e dei suoi diritti”[10]. Questo spiega anche il profondo dolore del Papa di fronte alle divisioni nelle società europee, sia a livello civile che religioso.
Sul piano civile, vanno ricordate in particolare le due terribili guerre mondiali, che smentirono in modo efferato il messaggio di pace della fede cristiana e distrussero l’unità dell’Europa a causa di letali nazionalismi. Non possono essere taciute neppure le due dittature del nazionalsocialismo e del comunismo sovietico, che divisero l’Europa tra Est e Ovest, causando una frattura la cui espressione più visibile fu la “cortina di ferro”. La “guerra fredda” tra le due maggiori superpotenze durò fino alla grande svolta del 1989, quando venne proclamata la “perestrojka”, soprattutto a Est. Lo stesso Mikhail Gorbaciov riconobbe apertamente il contributo significativo di Papa Giovanni Paolo II al crollo dei regimi comunisti dell’Europa orientale: “Ciò che è accaduto in Europa negli ultimi anni non sarebbe stato possibile senza questo Papa, senza Giovanni Paolo II, senza il ruolo politico di primo piano che ha svolto negli affari mondiali”.
La sofferenza maggiore in Papa Giovanni Paolo II era causata dal fatto che l’Europa fosse divisa anche per motivi religiosi, e questo da molto tempo nella storia. Egli pensava soprattutto alla profonda ferita provocata nell’XI secolo dallo scisma tra Oriente e Occidente nel continente europeo, sia a livello spirituale che ecclesiale. Il Papa espresse questa ferita con un’immagine eloquente: “Nell’unico organismo della Chiesa, i due polmoni avevano cessato di funzionare correttamente: ciascuno di essi aveva persino iniziato a formare qualcosa di simile a un proprio organismo”[11]. Il Papa trovava particolarmente tragico il fatto che questa divisione avesse determinato la vita intellettuale e spirituale dell’Europa cristiana dall’inizio del secondo millennio fino ai giorni nostri.
Ma Papa Giovanni Paolo II sentiva profondamente anche il peso delle fratture e divisioni emerse in Occidente all’inizio dell’era moderna, con i diversi movimenti di Riforma in vari paesi europei e anche con la separazione della Chiesa nelle Isole Britanniche dalla Sede di Pietro. L’Europa occidentale, che era stata un continente unito dal punto di vista religioso durante il Medioevo, si trovò ad affrontare gravi divisioni all’alba dell’era moderna, “che innescarono la realtà particolarmente triste delle guerre di religione e che si acuirono ulteriormente nei secoli successivi”[12].
Papa Giovanni Paolo II parlò della persistenza di tali divisioni nel continente europeo come di “uno degli scandali più grandi del nostro tempo”[13]. Considerava una grande sfida il fatto che, nell’Europa odierna messasi in cammino verso l’unità politica, fosse proprio la Chiesa di Gesù Cristo a rappresentare un fattore di divisione e di disunione. La Chiesa, spinta dall’Europa, deve dunque impegnarsi a ritrovare l’unità dei cristiani.
Eccoci giunti al motivo più profondo della presa di posizione appassionata di Papa Giovanni Paolo II a favore dell’ecumenismo[14]. Egli era guidato dalla ferma convinzione che, dopo il primo millennio di storia cristiana, tempo della Chiesa indivisa, e dopo il secondo millennio, tempo di laceranti divisioni all'interno della Chiesa sia in Oriente che in Occidente, al terzo millennio spettasse il grande compito di riscoprire l’unità perduta dei cristiani. Davanti a questa grande responsabilità, Giovanni Paolo II era altrettanto convinto che il ministero affidato al Successore di Pietro fosse anche il ministero dell’unità, e che esso assumesse una rilevanza del tutto speciale nel contesto dell’ecumenismo. Di fatti, il ripristino dell’unità non può essere semplicemente fine a sé stesso; per il Papa, si trattava “in un certo senso del futuro del mondo, del futuro del Regno di Dio nel mondo”. Le debolezze e i pregiudizi umani non devono quindi “distruggere il disegno divino per il mondo e per l’umanità”[15].
4. L’impegno a favore di una nuova Costituzione europea
Dopo l’incoraggiante ricostruzione dell’Europa a seguito della seconda guerra mondiale, ricostruzione segnata di nuovo dall’orientamento al cristianesimo, e dopo la svolta del 1989, si assisté in Europa a una forte sterzata verso il marxismo, con le sue promesse ingannevoli; ciò secolarizzò ampiamente la fede cristiana, trasformandola in un’ideologia terrena. Successivamente, si verificò un’altra forte ondata di secolarizzazione, che condusse a una diffusa erosione del cristianesimo nel continente europeo. Ciò divenne particolarmente evidente nei dibattiti intorno al preambolo della Costituzione europea, in cui il riferimento a Dio e il riconoscimento delle radici cristiane dell’Europa furono oggetto di accese discussioni.
In questo contesto, Papa Giovanni Paolo II insisté con determinazione sul fatto che la futura Costituzione europea dovesse includere un riferimento all’Europa religiosa e, in particolare, a quella cristiana. Al riguardo, egli domandò che il patto, nel pieno rispetto dell’indipendenza delle istituzioni statali, sancisse il diritto delle Chiese e delle Comunità religiose di organizzarsi liberamente, secondo le proprie convinzioni e i propri statuti. Ritenendo che il buon ordine sociale dovesse essere radicato in autentici valori morali e che, di conseguenza, l’Unione Europea non potesse durare se limitata alla mera dimensione geografica ed economica, egli promosse soprattutto la rivitalizzazione dei valori umani e cristiani, che devono trovare espressione nella vita e nel diritto. Giovanni Paolo II osservò che l'Europa non era sostenibile solo con l’euro quale nuova moneta comune, ma aveva bisogno anche di una moneta intellettuale e spirituale, che poteva trovare il suo fondamento nella tradizione cristiana di Dio come radice da cui la cultura europea è stata segnata in modo decisivo.
Questi postulati caddero spesso nel vuoto, soprattutto nella politica europea, sorda a tali priorità. Invece di ricordare le radici cristiane dell’Europa nell’edificare i suoi nuovi fondamenti, si tende a voler plasmare l’identità europea intorno alla cultura illuminista radicale, che ha ormai raggiunto il suo pieno potenziale. In questa diffusa volontà di escludere il cristianesimo dalla storia europea del XX secolo, il Papa ravvisò anche forze distruttive che, pur diluendosi verso la fine del secolo, hanno lasciato dietro di sé una “devastazione delle coscienze con conseguenze disastrose” negli ambiti della morale personale e familiare, come pure nel campo dell’etica sociale. Perciò Papa Giovanni Paolo II definì l’Europa alla soglia tra i due millenni un “continente di devastazioni”[16].
5. La necessità di una nuova evangelizzazione dell’Europa
Se vogliamo sanare tali ferite, non possono bastare programmi politici, soprattutto se incentrati esclusivamente su sviluppi economici. Piuttosto, la Chiesa è chiamata ad assumersi la sua responsabilità. Papa Giovanni Paolo II, così come riconosceva già nell’evangelizzazione la forza più potente per la formazione dell’identità cristiana nel corso della storia dell’Europa, vedeva anche nella nuova evangelizzazione del continente europeo il compito più importante della Chiesa ai suoi tempi. In tutto il suo lungo pontificato, infatti, egli la incoraggiò e la postulò, fin dal suo grande discorso a Santiago de Compostela nel 1989, dove lanciò appunto un appello a una “nuova evangelizzazione” in Europa[17].
Per comprendere meglio questo progetto di nuova evangelizzazione dell’Europa, dobbiamo prima ripercorrere brevemente le sfide che l’Europa deve affrontare e che troviamo elencate da Papa Giovanni Paolo II nella sua esortazione apostolica postsinodale “Ecclesia in Europa”. In primo luogo, nel testo egli parla di un offuscamento della speranza in Europa, che affonda le sue radici più profonde nel tentativo di imporre “un’antropologia senza Dio e senza Cristo”, avente conseguenze fatali per l’immagine dell’umanità: “L’aver dimenticato Dio ha portato ad abbandonare l’uomo”[18]. Sullo sfondo di questo sviluppo, egli individua una crescente dimenticanza dell’eredità cristiana, che porta a presentare la cultura europea come ampiamente distaccata dal contributo del cristianesimo. Il Papa osserva che allo smarrimento della memoria cristiana si accompagna “una sorta di paura di affrontare il futuro”, che sfocia essenzialmente in una “drammatica diminuzione della natalità” e nel soggiacente fenomeno delle “crisi familiari”[19].
Alla luce di questo scenario di sfide, risulta evidente in cosa dovesse consistere, per Papa Giovanni Paolo II, la necessaria nuova evangelizzazione in Europa. Con coerenza, egli in primo luogo sottolineò che l’Europa aveva bisogno di una “dimensione religiosa”. La nuova evangelizzazione deve quindi toccare la verità integrale dell’uomo ed essere strettamente legata all’antropologia, nel senso che la religione non è una sorta di epifenomeno dell’umano, dunque trascurabile, ma è costitutiva di ciò che è umano a tal punto che l’uomo non può essere compreso senza la dimensione religiosa. Papa Giovanni Paolo II era convinto che solo Gesù Cristo, attraverso la sua umanità, rivelasse il vero mistero dell’uomo fino al suo nucleo più profondo, motivo per cui lo sviluppo e l’annuncio di un’antropologia cristocentrica devono essere il motore della nuova evangelizzazione nella cultura europea. Solo così l'Europa, in un “atteggiamento di fedeltà creativa”, potrà riscoprire e ravvivare la sua tradizione umana e cristiana, che consiste nella salvaguardia del “primato dei valori etici e spirituali”[20].
Questo breve accenno al contenuto della nuova evangelizzazione dimostra in definitiva che tutto l’impegno di Papa Giovanni Paolo II a favore del continente europeo e della rivitalizzazione delle sue radici spirituali e, più specificamente, cristiane risiede nell’appello rivolto all’Europa a riscoprire sé stessa partendo dalla sua eredità cristiana. Egli condensò questo appello in un grido spirituale espresso durante la sua omelia a Santiago de Compostela nel 1982 e da allora costantemente ripetuto: “io, successore di Pietro nella Sede di Roma, Sede che Cristo volle collocare in Europa e che l’Europa ama per il suo sforzo nella diffusione del Cristianesimo in tutto il mondo; io, Vescovo di Roma e Pastore della Chiesa universale, da Santiago, grido con amore a te, antica Europa: ‘Ritrova te stessa. Sii te stessa’. Riscopri le tue origini. Ravviva le tue radici. Torna a vivere dei valori autentici che hanno reso gloriosa la tua storia e benefica la tua presenza negli altri continenti. Ricostruisci la tua unità spirituale, in un clima di pieno rispetto verso le altre religioni e le genuine libertà. Rendi a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Non inorgoglirti delle tue conquiste fino a dimenticare le loro possibili conseguenze negative; non deprimerti per la perdita quantitativa della tua grandezza nel mondo o per le crisi sociali e culturali che ti percorrono. Tu puoi essere ancora faro di civiltà e stimolo di progresso per il mondo. Gli altri continenti guardano a te e da te si attendono la risposta che san Giacomo diede a Cristo: ‘Lo posso’”[21].
Questo ambizioso obiettivo potrà essere realizzato solo se l’Europa riscoprirà la sua anima. Convinto di ciò, Papa Giovanni Paolo II condivideva la stessa visione di Jacques Delors, ex Presidente della Commissione Europea, e anche dei padri fondatori della nuova Europa, come Konrad Adenauer, Robert Schumann, Alcide de Gasperi e Jean Monet, che contribuirono alla ricostruzione dell’Europa dopo gli orrori e le devastazioni della seconda guerra mondiale, sicuri che il successo sarebbe stato possibile solo se l’Europa fosse tornata alle proprie origini, comprese le sue radici cristiane[22]. Come queste importanti figure, anche Papa Giovanni Paolo II può essere annoverato tra i grandi europei.
[1] Giovanni Paolo II, Ecclesia in Europa, n. 108.
[2] Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al V Simposio del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, il 5 ottobre 1982.[3] Johannes Paul II., Erinnerung und Identität. Gespräche an der Schwelle zwischen den Jahrtausenden (Augsburg 2005) 122.[4] Giovanni Paolo II, Discorso durante l’Atto Europeistico a Santiago de Compostela, il 9 novembre 1982.
[5] Giovanni Paolo II, omelia durante la concelebrazione eucaristica in occasione dell’apertura della II Assemblea speciale per l’Europa del Sinodo dei Vescovi, il 1⁰ ottobre 1999.
[6] Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti alla Riunione di Consultazione dell’Assemblea Speciale per l’Europa del Sinodo dei Vescovi, il 5 giugno 1990.
[7] Giovanni Paolo II, Omelia durante la Celebrazione eucaristica di chiusura della II Assemblea Speciale per l’Europa del Sinodo dei Vescovi, il 23 ottobre 1999.
[8] Johannes Paul II., Erinnerung und Identität. Gespräche an der Schwelle zwischen den Jahrtausenden (Augsburg 2005) 126.[9] Ibid 140.
[10] Giovanni Paolo II, Omelia durante la Celebrazione eucaristica di chiusura della II Assemblea Speciale per l’Europa del Sinodo dei Vescovi, il 23 ottobre 1999.
[11] Johannes Paul II., Erinnerung und Identität. Gespräche an der Schwelle zwischen den Jahrtausenden (Augsburg 2005) 125.[12] Ibid 125-126.
[13] Giovanni Paolo II, Omelia durante la Celebrazione ecumenica in occasione dell’Assemblea Speciale per l’Europa del Sinodo dei Vescovi, il 7 dicembre 1991.
[14] Vgl. K. Kardinal Koch, Der ökumenische Weg der Kirche im Dritten Jahrtausend. Die Leidenschaft von Papst Johannes Paul II. für die Einheit der Christen, in: Ders., Wohin geht die Ökumene? Rückblicke – Einblicke – Ausblicke (Regensburg 2021). 72-93.
[15] Johannes Paul II., Die Schwelle der Hoffnung überschreiten (Hamburg 1994) 178.
[16] Johannes Paul II., Erinnerung und Identität. Gespräche an der Schwelle zwischen den Jahrtausenden (Augsburg 2005) 152.[17] Giovanni Paolo II, Discorso durante l’Atto Europeistico a Santiago de Compostela il 9 novembre 1982.
[18] Johannes Paul II., Ecclesia in Europa, n. 9.
[19] Ibid n. 8.
[20] Giovanni Paolo II, Omelia durante la Solenne Celebrazione di chiusura della II Assemblea Speciale per l’Europa del Sinodo dei Vescovi, il 23 ottobre 1999.
[21] Giovanni Paolo II, Discorso durante l’Atto Europeistico a Santiago de Compostela, il 9 novembre 1982.
[22] Cfr. Pontificio Comitato di Scienze storiche (Ed.), Padri dell’Europa. Alle radici dell’Unione Europea (Città del Vaticano 2010).