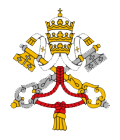IL CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE TEOLOGICHE ALL´ECUMENISMO
Discorso durante la cerimonia di conferimento del Dottorato honoris causa
da parte della Facoltà di Teologia della
Pontificia Università della Santa Croce
Roma, 7 ottobre 2025
Stimato Gran Cancelliere, Reverendo Monsignor Fernando Ocáriz,
Stimato Rettore, Reverendo Professor Fernando Puig,
Stimato Decano, Reverendo Professor Giulio Maspero,
Cari docenti e studenti,
Cari fratelli e sorelle,
Le mie prime parole sono di ringraziamento per il grande onore che mi avete concesso conferendomi il titolo di Dottore Honoris Causa in Teologia. È per me motivo di vera gioia ricevere questo riconoscimento nella rinomata Pontificia Università della Santa Croce, il cui nome ci ricorda che la Croce di Gesù Cristo è per noi, come dice Paolo, “potenza di Dio e sapienza di Dio” (1 Cor 1,24). Il conferimento di questo dottorato honoris causa da parte della Facoltà di Teologia è anche una gradita opportunità per menzionare brevemente il senso e la missione della teologia cristiana, soprattutto in riferimento alla ricomposizione dell’unità della Chiesa.
La necessità della formazione ecumenica
Il Concilio Vaticano II, con il suo Decreto sull’ecumenismo “Unitatis redintegratio”, ha sottolineato con fermezza che la teologia può offrire un contributo significativo all’adempimento di questo importante compito: “La cura di ristabilire l’unione riguarda tutta la Chiesa, sia i fedeli che i pastori, e tocca ognuno secondo le proprie possibilità, tanto nella vita cristiana di ogni giorno quanto negli studi teologici e storici”[1].
Affinché la teologia possa assolvere tale compito, deve prestare particolare attenzione alla formazione ecumenica. La necessità di quest’ultima è chiaramente sottolineata nel “Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo” che, pubblicato dall’allora Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani nel 1993, le dedica l’intero capitolo III. L’obiettivo principale è la formazione ecumenica di tutti i battezzati: “Scopo della formazione ecumenica è che tutti i cristiani siano animati dallo spirito ecumenico, qualunque sia la loro particolare missione e la loro specifica funzione nel mondo e nella società”[2]. Nell’aiutare la Chiesa a conseguire tale scopo, il Direttorio pone particolare enfasi sulla formazione ecumenica dei futuri operatori pastorali. Per sottolineare ulteriormente questo dovere, il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani ha pubblicato un documento specifico nel 1998, “La dimensione ecumenica nella formazione di chi si dedica al ministero pastorale”.
In questi documenti viene fatta la distinzione tra un corso specifico sull’ecumenismo, in cui si affrontano i fondamenti, i metodi e gli obiettivi dell'ecumenismo, e l'esplorazione della dimensione ecumenica contenuta, e da sviluppare, nell'insegnamento di ciascuna disciplina teologica. I due compiti sono interdipendenti. Da un lato, un corso specifico sull'ecumenismo può essere fruttuoso solo se riprende e approfondisce la dimensione ecumenica che è stata sviluppata nelle singole discipline teologiche. Dall’altro, è necessario che la dimensione ecumenica delle singole discipline teologiche sia inserita all’interno di un contesto sistematico in un corso separato, perché abbia un effetto concreto nel lavoro ecumenico. Qui di seguito, mi soffermerò non tanto sulla strutturazione di un corso ecumenico specifico, quanto sulla dimensione ecumenica delle discipline teologiche.
La dimensione ecumenica delle discipline storiche e sistematiche
Innanzitutto, dovrebbe essere evidente che le discipline legate alla storia della Chiesa hanno una dimensione ecumenica fondamentale. Infatti, senza una conoscenza storica dei vari scismi nella Chiesa e del movimento ecumenico, la priorità ecumenica non potrebbe essere compresa. Nelle discipline storiche è necessario esaminare, in modo particolare, anche i fattori non teologici che hanno contribuito in modo rilevante alle divisioni all’interno della Chiesa. In questo senso, già molto tempo fa, il teologo domenicano Yves Congar ha evidenziato che i processi di allontanamento culturale sono stati in larga misura co-responsabili della divisione nella Chiesa tra Oriente e Occidente; di fatti, le lacerazioni all’interno del cristianesimo non hanno avuto origine principalmente dalle dispute intorno alle diverse formulazioni dottrinali, ma sono sorte a causa del crescente fossato tra le rispettive pratiche di vita[3]. Gli studi hanno dimostrato, ad esempio, che né nel 1054 né in seguito si verificò uno scisma nella Chiesa tra Occidente e Oriente in senso proprio, ma che il divario tra culture diverse portò a un’alienazione sempre maggiore e, in ultima analisi, alla separazione. In questo contesto, il Decreto sull’ecumenismo sottolinea: “L’insegnamento della sacra teologia e delle altre discipline, specialmente storiche, deve essere impartito anche sotto l'aspetto ecumenico, perché abbia sempre meglio a corrispondere alla verità dei fatti”.[4]
Altrettanto evidente dovrebbe essere l’importante dimensione ecumenica che caratterizza le discipline afferenti alla teologia sistematica. Ciò può essere testimoniato dai vari dialoghi ecumenici in cui, negli ultimi sessant’anni, sono stati redatti e pubblicati numerosi documenti di consenso e convergenza su questioni attinenti alla fede cristiana e all’ordinamento ecclesiale, a riprova del contributo decisivo che la teologia sistematica ha apportato alla ricomposizione dell’unità dei cristiani. Ciò che, in riferimento all’ecumenismo, può essere detto della teologia sistematica in generale, vale in particolare per l’ecclesiologia, che figura sempre più al centro dei dialoghi ecumenici.
Vi è un ampio consenso sul fatto che le discipline storiche e sistematiche siano essenziali per l’ecumenismo. Tuttavia, anche altre discipline teologiche sono in grado di apportare contributi significativi all’attività ecumenica. È quanto illustrerò qui di seguito, come esemplificazione, prendendo in esame due discipline teologiche in cui questo aspetto potrebbe essere meno ovvio, almeno a prima vista, ma all’interno delle quali possono essere svolti compiti importanti: vale a dire, le scienze liturgiche e la teologia del diritto canonico.
La dimensione ecumenica delle scienze liturgiche
Persino più importante della dimensione ecumenica della teologia sistematica è la dimensione ecumenica della dossologia, la lode liturgica rivolta a Dio, in cui i cristiani di diverse Chiese possono avvicinarsi gli uni agli altri ancora di più che nel solo campo teologico. È proprio alla luce della liturgia che si chiarisce come l’impegno ecumenico concepisce sé stesso, conformemente alla convinzione espressa dal Concilio Vaticano II: “Bisogna conoscere l’animo dei fratelli separati”. Tale convinzione costituisce il prerequisito per qualsiasi dialogo ecumenico, secondo l’affermazione del decreto del Concilio Vaticano II sull’ecumenismo, che incoraggia i cattolici ad acquisire “una migliore conoscenza della dottrina e della storia, della vita spirituale e liturgica, della psicologia religiosa e della cultura propria dei fratelli”.[5]
La riflessione teologica sulla liturgia rivela in modo particolare l’essenza più intima del dialogo ecumenico, che non corrisponde a un mero scambio di idee, pensieri e teorie, ma consiste in un arricchente scambio di doni. Poiché le diverse Chiese e Comunioni ecclesiali conservano senza dubbio i loro doni più preziosi nella vita liturgica e la loro maggiore ricchezza nelle loro liturgie, lo scambio ecumenico di doni liturgici tra le diverse Comunioni di fede cristiane è anche uno dei compiti che le scienze liturgiche dovrebbero prefiggersi.[6]
Lo capiamo già da un breve sguardo alla storia, in cui è avvenuto tale scambio ecumenico di doni liturgici. Se ricordiamo i principi della Costituzione sulla sacra liturgia del Concilio Vaticano II, “Sacrosanctum Concilium”, e della riforma liturgica postconciliare, ci rendiamo presto conto che la Chiesa cattolica ha tratto ispirazione dalle liturgie di altre Chiese. Le liturgie delle Chiese e delle Comunioni ecclesiali nate dalla Riforma hanno certamente influito in modo significativo sulla riscoperta dell’importanza particolare della Parola di Dio e del suo ruolo nella liturgia della Chiesa cattolica. A partire dal Concilio Vaticano II, la centralità della Parola di Dio nella liturgia della Chiesa cattolica è diventata evidente e ha trovato espressione anche nella Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione, “Dei verbum”, che esplicita il legame essenziale tra l’annuncio della Parola di Dio e la liturgia, in particolare l’Eucaristia, affermando: “La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli”.[7]
Anche le liturgie delle Chiese ortodosse e ortodosse orientali hanno avuto un influsso fecondo sulla teologia e sulla celebrazione liturgica della Chiesa cattolica, come è chiaramente riscontrabile nei rispettivi approcci alla liturgia. Nella pratica liturgica, così come nelle scienze liturgiche della tradizione occidentale, l’attenzione è rivolta in gran parte all’assemblea dei fedeli e, di conseguenza, a come la liturgia debba essere strutturata affinché possa rendere giustizia alla consapevolezza che i fedeli hanno della propria fede. Diversamente da questa forte enfasi posta sulla dimensione comunitaria, nella tradizione della Chiesa orientale la liturgia è sempre intesa anche, e persino principalmente, come un evento cosmico, nel senso che la liturgia, soprattutto quella eucaristica, prefigura l’inno escatologico di lode dell’intero cosmo, e la liturgia celeste irrompe già nella liturgia terrena della Chiesa ed è in essa presente, così che cielo e terra si toccano. Nella visione delle Chiese orientali, la liturgia è molto più del raduno di una comunità più o meno numerosa di persone. Piuttosto, essa viene celebrata nella vastità del cosmo, abbracciando simultaneamente storia e creazione e rendendo poroso il confine tra liturgia celeste e liturgia terrena.
Gli esempi menzionati mostrano l’influenza delle liturgie di altre Chiese sulla liturgia della Chiesa cattolica. Uno scambio di doni liturgici può, naturalmente, essere osservato anche nella direzione inversa. La teologia e la pratica liturgica della Chiesa cattolica dopo il Concilio Vaticano II hanno agevolato un più facile approccio all’interpretazione e alla definizione della Cena del Signore come Eucaristia anche nelle Chiese e nelle Comunioni ecclesiali nate dalla Riforma, e hanno fatto sì che la preghiera eucaristica venisse recuperata all’interno della liturgia della Cena del Signore e quindi accolta come fulcro di tale celebrazione.
Come conseguenza positiva di questo sviluppo, che F. Schulz ha giustamente descritto come “frutto della convergenza ecumenica”[8], possiamo menzionare il fatto che la preghiera eucaristica della Chiesa primitiva, tratta dall’Ordinamento ecclesiastico di Ippolito, sia stata incorporata nelle raccolte di preghiere eucaristiche dagli anglicani inglesi e americani, dai luterani americani e dalla Chiesa riformata della Svizzera francese, diventando così una preghiera eucaristica quasi ecumenica. Strettamente legato a ciò è il fatto che il concetto di sacrificio nella teologia e nella liturgia della Chiesa cattolica, orientata verso quello orientale di anafora, ha contribuito alla scoperta di un nuovo approccio all’idea di sacrificio nelle Chiese e nelle Comunioni ecclesiali nate dalla Riforma, dove la dimensione sacrificale dell’Eucaristia era stata aspramente contestata nel corso della storia, soprattutto durante il periodo della Riforma; questo ha fornito un rinnovato impulso all’interpretazione biblica di sacrificio, secondo cui Dio stesso dona ciò che noi gli doniamo, ma anche noi esseri umani doniamo veramente, o meglio restituiamo a Dio ciò che egli ci ha donato.[9]
Se teniamo presente questo scambio ecumenico di doni liturgici, comprendiamo che è possibile attingere ancora più profondamente alle scienze liturgiche come energia vitale per il riavvicinamento ecumenico tra i cristiani. Ciò è particolarmente evidente se si considera che il dolore per le persistenti divisioni all’interno della Chiesa e per la tutt’ora mancante piena comunione tra i cristiani non è in nessun luogo più tangibilmente sentito che nella vita liturgica delle varie Chiese e Comunioni ecclesiali, soprattutto nella sua forma sacramentale-eucaristica. Il Cardinale Augustin Bea, primo Presidente dell’allora Segretariato per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, espresse con sensibilità questo dolore, affermando che il “sacramentum unitatis” era diventato “segno dell’unità perduta”. In effetti, anche la mancata unità tra i fedeli è visibile nelle liturgie delle diverse Chiese e Comunioni ecclesiali, tanto che si deve quasi parlare di una “epifania di empie divisioni”[10]. Questa constatazione è senza dubbio un buon motivo per approfondire la dimensione ecumenica delle scienze liturgiche, al servizio dell’unità dei cristiani.
La dimensione ecumenica del diritto canonico
Passiamo ora alla seconda disciplina teologica, che presenta anch’essa una dimensione ecumenica essenziale, ovvero la teologia del diritto canonico. Che anche il diritto canonico sia al servizio del ristabilimento dell’unità dei cristiani traspare già dal fatto che per Papa Giovanni Paolo II esso è stato uno dei principi guida decisivi nella codificazione del diritto della Chiesa universale, e dal fatto che il Codice di Diritto Canonico (CIC) del 1983 prevede esplicitamente l’obbligo per la Chiesa cattolica di partecipare al movimento ecumenico.[11] Là viene espressamente sottolineato che la Chiesa è “tenuta per volontà di Cristo”[12] a promuovere il ristabilimento dell’unità di tutti i cristiani; pertanto, l’obbligo ecumenico della Chiesa cattolica è fondato sul testamento di Gesù, tanto che si può parlare di un obbligo ecumenico iure divino.
Rispetto al Codex Iuris Canonici del 1983 per la Chiesa latina, l’obbligo giuridico della Chiesa di partecipare al movimento ecumenico è formulato ancora più chiaramente nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO), il codice giuridico per le Chiese orientali cattoliche promulgato da Papa Giovanni Paolo II nel 1990. Questo, sotto tre aspetti[13]: in primo luogo, il suo importante significato dal punto di vista ecumenico risiede nel fatto che, per la prima volta nella storia, la Chiesa cattolica si dota di due diversi codici giuridici e quindi riconosce una certa pluralità giuridica. In secondo luogo, a differenza del CIC, che non contiene una sezione sistematica distinta sull’impegno ecumenico, ma fa riferimento a questioni ecumeniche in varie norme e colloca l’obbligo ecumenico principalmente all’interno del ministero dell’annuncio evangelico della Chiesa, il CCEO, oltre a singoli canoni significativi su temi ecumenici, dedica un titolo separato alla missione ecumenica della Chiesa, il Titolo XVIII, “L’ecumenismo ovvero la promozione dell’unità dei cristiani”[14]. Nel canone 902, fondamentale, tutti i credenti cristiani, e in particolare i pastori della Chiesa, “devono pregare il Signore per questa desiderata pienezza di unità della Chiesa e darsi da fare partecipando ingegnosamente all’attività ecumenica suscitata dalla grazia dello Spirito Santo”.
In terzo luogo, da un punto di vista ecumenico, è molto eloquente la limitazione temporale della validità del CCEO e quindi la sua natura transitoria. Già il decreto del Concilio Vaticano II sulle Chiese cattoliche orientali, “Orientalium Ecclesiarum”, afferma, nelle sue conclusioni, che tutte le disposizioni giuridiche in esso contenute si applicano solo alla situazione presente, “fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate si uniscano nella pienezza della comunione”.[15] Sulla stessa scia, Papa Giovanni Paolo II, nella sua Costituzione Apostolica “Sacri canones”, ha osservato che i canoni di tale Codice hanno validità fino a che “saranno abrogati o verranno modificati dalle più alte autorità della Chiesa per giusti motivi”, il più importante dei quali è “la piena comunione di tutte le Chiese dell’Oriente con la Chiesa cattolica”[16]. Ciò evidenzia che la chiara limitazione temporale della validità del CCEO è posta in una prospettiva ecumenica e che le Chiese cattoliche orientali hanno una speciale responsabilità ecumenica, delineata esplicitamente nel Decreto conciliare sulle Chiese cattoliche orientali: “Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica romana compete lo speciale ufficio di promuovere l’unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto «sull'ecumenismo» promulgato da questo santo Concilio”.[17] La limitazione temporale della validità del CCEO significa quindi che, una volta raggiunta la piena comunione tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse e ortodosse orientali, il compito del CCEO sarà stato assolto e sarà necessario adottare un nuovo ordinamento giuridico.
Ecco un’incoraggiante visione ecumenica: l’elaborazione di un diritto canonico ecumenico. Questo, tuttavia, non è ancora possibile nella situazione attuale, poiché è necessario che prima si realizzi l’unità della Chiesa. Nella situazione attuale, può esserci solo un diritto ecumenico della Chiesa cattolica. Ma se viene preso sul serio l'obbligo fondamentale di tutti i battezzati di partecipare al movimento ecumenico, gli ulteriori progressi nella convivenza ecumenica dei cristiani potranno e dovranno portare anche a ulteriori sviluppi delle norme del diritto canonico. Fin da ora, comunque, l'obbligo giuridico di partecipare al movimento ecumenico rappresenta un grande aiuto nel tenere vivo e nel portare avanti uno dei compiti centrali del Concilio Vaticano II. I due testi giuridici indicano infatti che l’impegno ecumenico è un obbligo imprescindibile.
Quanto detto in merito al diritto canonico della Chiesa vale certamente per tutte le discipline teologiche: esse si intendono al servizio del ristabilimento dell’unità della Chiesa e apportano il loro contributo peculiare, adempiendo così al loro ruolo nel servire il dovere intellettuale e l’approfondimento della fede della Chiesa. La Chiesa non è primariamente né il tema né l’oggetto della teologia, ma molto più fondamentalmente il soggetto e lo spazio vitale in cui la teologia viene praticata. Chiesa e teologia sono quindi permanentemente interdipendenti: “una Chiesa senza teologia diventa sempre più povera e cieca, ma una teologia senza Chiesa si disgrega nell’arbitrario”[18]. La teologia cristiana si attua sempre nella Chiesa e nasce dalla Chiesa e, in questo senso fondamentale, è teologia ecclesiale. Solo così può offrire il suo contributo insostituibile all’impegno ecumenico della Chiesa. Convinto che la Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce continui a comprendere e a vivere la sua missione in questo spirito, nelle sue diverse discipline, vi ringrazio ancora una volta per il grande onore conferitomi oggi sotto il segno della Santa Croce, nel quale l’unità della Chiesa è profondamente radicata.
[1] Unitatis redintegratio, n. 5.
[2] Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo, n. 58.
[3] Y. Congar, Zerstrittene Christenheit. Wo trennten sich Ost und West (Wien 1959).
[4] Unitatis redintegratio, n. 10.
[5] Unitatis redintegratio, n. 9.
[6] Cfr. K. Kardinal Koch, Liturgiereform und Einheit der christlichen Kirchen, in: G. W. Lathrop / M. Stuflesser (Hrsg.), Liturgiereformen in den Kirchen. 50 Jahre nach Sacrosanctum concilium = Theologie der Liturgie. Band 5 (Regensburg 2013) 111-124, Ders., Gabe und Aufgabe. Roms Liturgiereformen in ökumenischer Perspektive, in: St. Heid (Hrsg.), Operation am lebenden Objekt. Roms Liturgiereformen von Trient bis zum Vaticanum II (Berlin 2014) 11-26; Ders., Liturgie im Dienst der Einheit. Die Bedeutung der Liturgiewissenschaft für Theologie und Ökumene, in: H.-J. Feulner, D. Seper (Hrsg.), 50 Jahre Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie an der Universität Wien. Rückblicke – Einblicke – Ausblicke (Wien 2020) 25-44.
[7] Dei verbum, n. 21.
[8] F. Schulz, Das Eucharistiegebet in den Kirchen der Reformation als Frucht ökumenischer Konvergenz. Rezeption und Revision, in: K. Schlemmer (Hrsg.), Gemeinsame Liturgie in getrennten Kirchen (Freiburg i. Br. 1991) 82-118.
[9] Cfr. K. Lehmann und E. Schlink (Hrsg.), Das Opfer Jesu Christi und seine Gegenwart in der Kirche. Klärungen zum Opfercharakter des Herrenmahles = Dialog der Kirchen. Band 3 (Freiburg i. Br. – Göttingen 1983).
[10] T. Berger, Prolegomena für eine ökumenische Liturgiewissenschaft, in: Archiv für Liturgiewissenschaft 29 (1987) 1- 18, zit. 2.
[11] Cfr. W. Aymanns, Ökumenische Aspekte des neuen Gesetzbuches der Lateinischen Kirche Codex Iuris Canonici, in: AfrKR 151 (1982) 479-489, bes. 479-484; H. Hallermann (Hrsg.), Ökumene und Kirchenrecht – Bausteine oder Stolpersteine? (Mainz 2000); W. Kasper, Diritto canonico ed ecumenismo, in: M. Graulich (Hrsg.), Il Codice di Diritto canonico al servizio della missione della Chiesa (Roma 2008) 53-69.
[12] Canone 755 § 1 CIC/1983.
[13] Cfr. K. Koch, L’incidenza del CCEO sul dialogo ecumenico, in: Pontificio Consiglio per i testi legislativi (ed.), Il Codice delle Chiese orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche. Atti del Convegno di studio tenutosi nel XX anniversario della promulgazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Città del Vaticano 2011) 43-50.
[14] Canoni 902-908 CCEO.
[15] Orientalium ecclesiarum, n. 30.
[16] Giovanni Paolo II, Constitutio Apostolica „Sacri canones” del 18 ottobre 1990.
[17] Orientalium ecclesiarum, n. 24.
[18] J. Cardinal Ratzinger, Vom geistlichen Grund und vom kirchlichen Ort der Theologie, in: Ders., Wesen und Auftrag der Theologie. Versuche zu ihrer Ortsbestimmung im Disput der Gegenwart (Einsiedeln 1993) 39-62, zit. 41.