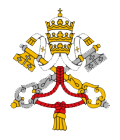Conferenza in occasione del conferimento del titolo di Doctor honoris causa
Facoltà di Teologia dell’Università di Valencia
(7 novembre 2024)
El Concilio Vaticano II entre tradición y modernidad
Excelentísimo Gran Canciller Arzobispo Enrique Benavent
Excelentísimo señor Nuncio apostólico de S.S., arzobispo Auza
Excelentismo vice Canciller Frater Jesús Diáz Sariego OP
Magnífico y estimado Rector Pagán Agulló
Estimado Señor Decano Santiago Pons
Estimado Director Andrés Valencia Pérez
Excelencias, autoridades académicas, cíviles y militares
Queridos profesores y estudiantes
Queridos hermanos y hermanas
Quiero, en primer lugar, expresar mi sincera gratitud por el gran honor que me conceden al otorgarme el título de Doctor Honoris Causa con motivo de la celebración del 50º aniversario de la fundación de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, que durante estos años ha brindado una gran contribución teológica al servicio de la Iglesia española. Agradezco a todos los que han tomado la iniciativa y a todos los que han contribuido a la preparación y a la ceremonia de entrega. Es un placer especial para mí recibir este reconocimiento de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, junto con la Cátedra Yves Congar. Ambas llevan los nombres de famosos dominicos que estuvieron particularmente comprometidos con la causa de la verdad de la fe. Por tanto, me gustaría agradecerles presentando mis reflexiones teológicas sobre la importancia duradera del Concilio Vaticano II para la Iglesia y la teología. Casi sesenta años después de la conclusión de este Concilio, me parece oportuno que nos preguntemos una vez más cuál es hoy el impacto de este fundamental Concilio eclesial del siglo XX. Teniendo un especial recuerdo y m´s oraciones por todos que han sufrido DANA el pasado octubre aquì en Valencia.
1. Il programma teologico fondamentale del Concilio
In primo luogo, vale la pena ricordare il primo grande tentativo di sintesi intrapreso dal Sinodo straordinario dei Vescovi nel 1985. Nella sua valutazione complessiva della situazione della Chiesa a vent’anni dalla conclusione del Vaticano Secondo, il Sinodo sviluppò coerentemente gli approcci conciliari giungendo a una rinnovata ecclesiologia di comunione, nella quale, secondo Joseph Ratzinger, si può percepire “l’effettivo fulcro della visione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa”[1]. Tramite il concetto-guida di comunione, il Sinodo dei Vescovi interpretò il programma fondamentale del Concilio, esposto soprattutto nelle quattro grandi Costituzioni, sottolineando la loro interconnessione organica e la loro armonia sinfonica ed esprimendo ciò nella memorabile formula: “La Chiesa (Costituzione sulla Chiesa) – sotto la Parola di Dio (Costituzione sulla Rivelazione) - celebra i misteri di Cristo (Costituzione sulla Liturgia) - per la salvezza del mondo (Costituzione sulla Pastorale).”[2]
a) La sinfonia delle quattro Costituzioni
Questa formula rivela la chiara architettura delle quattro Costituzioni. Il fatto che la Costituzione sulla liturgia “Sacrosanctum Concilium” sia la prima fu inizialmente dovuto a ragioni pragmatiche, perché si presumeva che non ci sarebbero state grandi controversie sulla liturgia durante il Concilio. Ad esempio, il Cardinale Giovanni Battista Montini, che come Papa Paolo VI realizzò la riforma liturgica post-conciliare, nel presentare la sua lista di temi all’inizio del Concilio, dichiarò di non considerare la liturgia e la sua riforma come un compito essenziale del Concilio. Tuttavia, la riforma liturgica fu ben presto riconosciuta come “l’opera riformatrice più visibile e duratura del Concilio”[3]. In quest’ottica, Papa Giovanni Paolo II sottolineò, nella sua Lettera apostolica “Vicesimus quintus annus”, che nella Costituzione sulla Liturgia si poteva già ravvisare “la sostanza di quella dottrina ecclesiologica, che sarà successivamente proposta dall’assemblea conciliare”; e ne concluse: “Esiste, infatti, un legame strettissimo e organico tra il rinnovamento della liturgia e il rinnovamento di tutta la vita della Chiesa.”[4] Pertanto, guardando indietro al fatto che la Costituzione sulla Liturgia si situa all’inizio del Concilio, possiamo affermare che, nella Chiesa, è l’adorazione, e quindi Dio, a collocarsi in prima posizione.
Il fatto che l’essenza stessa della Chiesa derivi dal compito fondamentale della liturgia, ovvero quello di glorificare Dio, è il tema della Costituzione dogmatica sulla Chiesa “Lumen Gentium”. Anche questa Costituzione ha una struttura elaborata e teologicamente ben concepita, in quanto si articola per così dire per cerchi concentrici[5]: il primo capitolo tratta il mistero della Chiesa e utilizza varie immagini a tal fine; a questo corrisponde l’ottavo capitolo, in cui il mistero della Chiesa si concretizza nella persona di Maria. Il secondo capitolo sul popolo di Dio è in rapporto con il settimo capitolo sul carattere escatologico della Chiesa pellegrina. Anche il terzo, il quarto e il sesto capitolo sull’episcopato, sul ruolo dei laici e sulla vita religiosa sono strettamente collegati tra loro. Il quinto capitolo sulla chiamata universale alla santità è al centro, è il punto cardine dell’insieme. Tale chiamata di tutti i battezzati viene sottolineata in modo così chiaro e universale che si può dire che rappresenti l’elemento più democratico della fede cattolica. Poiché il nome della Costituzione - “Lumen gentium” - non si riferisce alla Chiesa ma a Gesù Cristo, l’obiettivo fondamentale del Concilio è quello di presentare un’ecclesiologia coerentemente teo-logica, nel senso che il discorso sulla Chiesa deve essere subordinato al discorso su Dio.
La Costituzione sulla Divina Rivelazione “Dei Verbum” s’incentra sulla Parola viva di Dio, che convoca la Chiesa e la rivitalizza in ogni tempo. Delle quattro Costituzioni conciliari, è purtroppo la meno conosciuta e quella che ha prodotto meno frutti nella vita della Chiesa; tuttavia, come ha osservato il Cardinale Carlo M. Martini, può essere considerata “il più bel documento, forse, del Concilio”[6]. Infatti, come si legge già nella prefazione, la Chiesa ha proposto la dottrina della Divina Rivelazione e la sua trasmissione nella vita della Chiesa “affinché per l’annunzio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo speri, sperando ami”[7]. Con ciò emerge il fondamentale carattere personale della Rivelazione Divina, che non va intesa semplicemente come una comunicazione di verità. La Rivelazione è piuttosto l’azione storico-personale di Dio stesso, di cui la Sacra Scrittura e la Tradizione della Chiesa sono la mediazione storica. Per questo, Henri de Lubac si espresse su questa Costituzione in modo molto positivo: “Mai prima di allora un testo conciliare aveva sottolineato così bene il principio della Tradizione in tutta la sua ampiezza e complessità; mai prima di allora era stato riservato così tanto spazio alla Sacra Scrittura.”[8]
Il tema della Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo “Gaudiun et spes” è il modo in cui la Chiesa porta nel mondo la luce della Parola ricevuta da Dio e, annunciando il Vangelo della salvezza di Dio per l’uomo e per il mondo intero, promuove l’adorazione di Dio. Essa si rifà al mistero della Chiesa esposto nelle Costituzioni dogmatiche del Concilio e descrive la missione della Chiesa nel mondo, come si legge esplicitamente al capitolo 40: “In questo capitolo, pertanto, presupponendo tutto ciò che il Concilio ha già insegnato circa il mistero della Chiesa, si viene a prendere in considerazione la medesima Chiesa in quanto si trova nel mondo e insieme con esso vive ed agisce.”[9]
b) La relazione della Chiesa con il mondo
Nella Costituzione pastorale, il Concilio affrontò con fermezza la questione della relazione della Chiesa con il mondo. Tale questione sollevava grandi aspettative e, insieme, rappresentava una considerevole sfida, poiché, soprattutto a partire dal XIX secolo, il rapporto tra la Chiesa e l’età moderna, ormai pienamente dischiusasi, era andato peggiorando. Per chiarire la relazione della Chiesa con il mondo era quindi necessario chiarire anche la posizione della Chiesa tra tradizione e modernità. La riflessione differenziata del Concilio sui temi significativi del tempo moderno, come il rapporto tra fede e scienza moderna, il rapporto tra Chiesa e Stato e il problema della tolleranza religiosa e della libertà religiosa, è presente, più che nelle grandi Costituzioni dogmatiche, nella Costituzione pastorale “Gaudium et Spes” e ancor più nei documenti minori, soprattutto nella Dichiarazione sul rapporto della Chiesa con le religioni non cristiane “Nostra Aetate” e nella Dichiarazione sulla libertà religiosa “Dignitatis Humanae”. Per tale motivo, nell’ultimo grande discorso sul Concilio pronunciato durante il suo pontificato, Papa Benedetto XVI ha definito questi tre documenti come una “trilogia molto importante”, “la cui importanza si è mostrata solo nel corso dei decenni”[10].
Naturalmente va tenuto presente che ogni documento del Concilio deve essere considerato insieme agli altri ed interpretato alla luce della totalità dei testi. Ciò vale soprattutto per il rapporto tra le Costituzioni da un lato e i Decreti e le Dichiarazioni dall’altro, nel senso che questi ultimi, per lo più, sono la traduzione concreta, per la vita pratica della Chiesa, di questioni specifiche presenti nelle Costituzioni. Ad esempio, il Decreto sull’ecumenismo “Unitatis Redintegratio” è strettamente legato alla Costituzione dogmatica sulla Chiesa, come già sottolineò Papa Paolo VI al momento della sua promulgazione, affermando che questo Decreto spiega e completa la Costituzione dogmatica sulla Chiesa: “ea doctrina explicationibus completa”[11]. Usando tale espressione, Papa Paolo VI non attribuiva al Decreto sull’ecumenismo, come spesso si sostiene oggi, un valore teologico minore, ma lo collegava, nella sua importanza teologica, alla Costituzione dogmatica sulla Chiesa.
Nelle quattro Costituzioni e nei documenti minori, non meno significativi, il Concilio ha delineato il suo programma fondamentale, come è stato poi ribadito dal Sinodo straordinario dei Vescovi del 1985. Anche dopo sessant’anni, questo programma del Concilio non ha perso nulla della sua attualità. Questo Concilio è e rimane quindi la Magna Charta della Chiesa cattolica nel suo cammino storico nel terzo millennio, a condizione però che la lettera e lo spirito del Concilio non siano visti come separati dualisticamente, ma siano interpretati insieme.
2. La posizione speciale del Vaticano II nella storia dei Concili
La domanda su quale sia la situazione della Chiesa, dell’ecumenismo e della società a sessant’anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II si pone anche perché il Concilio Vaticano II occupa una posizione particolare nella storia dei Concili. Questo è evidente già alla luce di fattori numerici: mentre al Concilio Vaticano I erano presenti poco più di 600 Padri, al Concilio Vaticano II i Padri erano oltre 2.400, il che significa che il Vaticano II può essere considerato come la più grande assemblea ecclesiastica della storia. La Chiesa cattolica si presentò pertanto, in maniera significativa, come Chiesa universale. Inoltre, i testi che il Concilio Vaticano II adottò quali suoi autentici risultati sono così numerosi da costituire un quarto dei testi adottati da tutti i precedenti Concili ecumenici.
La posizione speciale del Concilio Vaticano II si rispecchia, ovviamente, non solo in questi fatti esterni, ma soprattutto nel suo obiettivo più profondo. Nel passato, i Concili erano solitamente convocati perché dovevano affrontare questioni specifiche e prendere risoluzioni al riguardo. Questo fu già il caso del primo Concilio ecumenico della storia della Chiesa, il Concilio di Nicea del 325, di cui, l’anno prossimo, verranno celebrati da tutta la cristianità i 1700 anni.[12] All’epoca, i motivi che spinsero a indire il Concilio furono, da un lato, la disputa scatenata dal teologo alessandrino Ario sulla confessione cristologica ortodossa e, dall’altro, questioni pratiche e disciplinari come, in particolare, la data di Pasqua. Alla base della convocazione del Concilio Vaticano II non ci fu, invece, un motivo concreto e Papa Giovanni XXIII non presentò al Concilio un programma dettagliato. Il Concilio si preoccupò piuttosto di una questione più fondamentale, ossia di infondere un rinnovato vigore alla fede cristiana in un mondo in cui essa sembrava perdere sempre più la sua dinamica costruttiva e di aprirla nuovamente alla società contemporanea, nella convinzione che la cristianità può recuperare la sua capacità di plasmare e segnare il mondo solo se si colloca con decisione nel presente. Questa intenzione è stata espressa in modo incisivo sia nel discorso di apertura di Papa Giovanni XXIII all’inizio del Concilio, l’11 ottobre 1962, sia nel discorso di chiusura di Papa Paolo VI alla fine del Concilio, il 7 dicembre 1965.
A questo obiettivo è legato anche il fatto che il Concilio Vaticano II non ha pronunciato condanne dottrinali o definizioni dogmaticamente vincolanti, ma si è autoconcepito soprattutto come un Concilio pastorale con l’intento di avvicinare agli uomini di allora, in maniera attraente e convincente, gli orientamenti del Vangelo e gli insegnamenti della Chiesa, che si considera “mater et magistra”. Sulla base di queste osservazioni, è del tutto legittimo affermare che il Concilio Vaticano II è stato un nuovo tipo di Concilio.
Tale posizione speciale va ricordata, almeno per sommi capi, soprattutto perché è in gran parte il motivo del fatto che durante il Concilio e soprattutto dopo la sua conclusione sono emerse interpretazioni molto diverse tra loro, e gli orientamenti del Concilio sono stati realizzati secondo modalità opposte. Tuttavia, poiché per la storia degli effetti di un Concilio nella vita della Chiesa è di fondamentale importanza che vi sia almeno un consenso sugli elementi fondamentali per quanto riguarda la corretta comprensione e l’adeguata interpretazione del Concilio, la questione deve essere ulteriormente approfondita.
3. Diverse ermeneutiche del Concilio Vaticano II
Le diverse e piuttosto contrastanti interpretazioni del Concilio Vaticano II sono state riassunte da Papa Benedetto XVI, che partecipò al Concilio come perito, contribuendovi attivamente[13], nel suo primo grande discorso tenuto in occasione della presentazione degli auguri natalizi al Collegio cardinalizio e alla Curia romana nel primo anno del suo pontificato. Egli fa la distinzione tra due opposte ermeneutiche conciliari, ovvero, da un lato, l’ “ermeneutica della discontinuità e della rottura” che respinge, e, dall’altro, l’ “ermeneutica della riforma”, che considera come il modo adeguato di interpretare e recepire il Concilio Vaticano Secondo.[14]
a) L’ermeneutica della discontinuità e della rottura
Chiunque cerchi di ripercorrere la storia della ricezione del Concilio Vaticano II riconoscerà facilmente l’efficacia dell’“ermeneutica della discontinuità e della rottura”. Non solo nei mass media, ma anche in molte correnti per così dire progressiste all’interno della Chiesa cattolica, essa è diventata predominante. Uno dei protagonisti più in vista di questa ermeneutica conciliare è stato senza dubbio il teologo di Tubinga Hans Küng, che intendeva il Concilio come “integrazione del paradigma della Riforma e della modernità nella Chiesa cattolica”. Poiché la modernità implica essenzialmente una rottura con la tradizione, secondo Küng l’interpretazione del Concilio Vaticano II in un senso compatibile con la modernità deve anch’essa implicare una rottura di fondo con la tradizione. Küng ha anche diagnosticato un grave “difetto di nascita” del Concilio Vaticano II e, a posteriori, ha definito l’importante assemblea ecclesiale come un “concilio con i suoi compromessi, le sue mezze misure e le sue ambiguità”, dichiarando quindi con enfasi che il Concilio stesso ci ha esortato a non fermarci ad esso, ma ad andare oltre per completare la rottura iniziata con il Concilio.[15]
Con l’“ermeneutica della discontinuità e della rottura”, il Concilio viene inteso come la fine della forma tradizionale di Chiesa conosciuta fino ad allora e come l’inizio di qualcosa di nuovo, che, seppur percepibile nello “spirito” del Concilio, non si sarebbe ancora concretizzato nei suoi documenti e avrebbe dovuto quindi essere realizzato dopo di esso. Questa ermeneutica si riconosce soprattutto dalla distinzione operata in modo eccessivo tra la cosiddetta Chiesa preconciliare e quella postconciliare. In una visione fortemente dualistica della storia, viene enfatizzata la discontinuità tra il periodo precedente e quello successivo al Concilio.
Tuttavia, anche i cosiddetti tradizionalisti, nello spirito dell’arcivescovo Marcel Lefebvre, interpretano il Concilio Vaticano II come una netta rottura con la tradizione, affermando che, con il Concilio, è comparsa una nuova Chiesa, ben diversa da quella precedente. Di conseguenza, essi ipotizzano e sostengono un’ermeneutica della continuità pura e astorica. In base a questa, vengono riconosciuti e accettati solo quegli insegnamenti del Concilio che si possono già rintracciare nella tradizione della Chiesa, mentre vengono respinti quelli – tra cui, in particolare, la libertà religiosa, il dialogo ecumenico e interreligioso – che non avrebbero alcun fondamento nella tradizione.
A prima vista sembra certamente paradossale, ma a un livello più profondo deve far riflettere il fatto che sia i progressisti, sia i tradizionalisti intendano il Concilio Vaticano II come una rottura con la tradizione, anche se in modo speculare. L’unica differenza è che, per i progressisti, la rottura avviene dopo il Concilio, mentre per i tradizionalisti essa ha luogo con il Concilio. Tuttavia, le due posizioni estreme – les extrèmes se touchent – sono così vicine proprio perché non interpretano il Concilio Vaticano II all’interno della tradizione complessiva della Chiesa. Papa Benedetto XVI ha descritto questa visione erronea in termini molto chiari: “Non si può congelare l’autorità magisteriale della Chiesa all’anno 1962 – ciò deve essere ben chiaro alla Fraternità. Ma ad alcuni di coloro che si segnalano come grandi difensori del Concilio deve essere pure richiamato alla memoria che il Vaticano II porta in sé l’intera storia dottrinale della Chiesa. Chi vuole essere obbediente al Concilio, deve accettare la fede professata nel corso dei secoli e non può tagliare le radici di cui l’albero vive.”[16]
b) L’ermeneutica della riforma
Questi sono i motivi fondamentali per cui Papa Benedetto XVI respinge l’ “ermeneutica della discontinuità e della rottura”; egli la considera “assurda, contraria allo spirito ed alla volontà dei padri conciliari”. I Padri conciliari, infatti, non potevano e non volevano “creare una fede diversa o una nuova Chiesa, ma solo comprendere più profondamente e, in tal modo, veramente ‘rinnovare’ entrambe” [17]. Va da sé, tuttavia, che Benedetto XVI non sostiene minimamente un’ermeneutica della pura continuità, come spesso invece si crede.
Egli chiama “ermeneutica della riforma” l’unica ermeneutica conciliare da lui ritenuta adeguata. Essa è contrassegnata dal fatto che prende sul serio la fedeltà alla tradizione della Chiesa tanto quanto la dinamica delle spinte innovatrici fornite dai promettenti nuovi approcci e dalle riforme del Concilio Vaticano II. Per lui, quindi, tradizione e progresso non sono contrapposti, ma si esigono e si promuovono a vicenda, come sottolinea parlando della liturgia: “la Tradizione è una realtà viva, include perciò in se stessa il principio dello sviluppo, del progresso. Come a dire che il fiume della Tradizione porta in sé sempre la sua sorgente e tende verso la foce.”[18] Pertanto, l’ermeneutica della riforma non solo ravvisa nel Concilio una continuità con la tradizione, ma riconosce anche la discontinuità nel presente e nel futuro. La natura della vera riforma emerge da questo gioco di continuità e discontinuità.
Il Concilio Vaticano II ha quindi inteso se stesso come un Concilio tra tradizione e modernità, ovvero come l’anello di una catena legata alla tradizione ma allo stesso tempo aperta al presente e al futuro. Da un lato, come tutti i Concili, ha voluto aderire alla tradizione della Chiesa e si è visto come un movimento all’interno di questa tradizione; altrimenti non sarebbe stato un Concilio della Chiesa cattolica. È dunque sua intenzione essere compreso e interpretato alla luce della tradizione complessiva e vivente.
Lo stretto nesso tra il Concilio e la tradizione della Chiesa appare chiaramente già dai documenti a cui il Concilio fa riferimento. Solo nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa “Lumen Gentium” vengono menzionati dieci Concili precedenti, con il Concilio Vaticano I citato dodici volte e il Concilio di Trento sedici volte. La presenza dei Padri della Chiesa è particolarmente forte nella “Lumen Gentium”, con oltre quaranta citazioni. Il nome di Papa Pio XII compare più di duecento volte nell’intero corpo dei testi conciliari; insieme alle Sacre Scritture, è la fonte più citata nei documenti conciliari. Papa Pio XII, che aveva avuto lui stesso l’intenzione di convocare un Concilio, è di fatti molto presente nel Concilio Vaticano II con la sua eredità intellettuale. Questi pochi esempi vogliono solo illustrare quanto i Padri conciliari si considerassero parte della tradizione della Chiesa e quanto il Concilio Vaticano II fosse orientato verso la grande e viva tradizione della Chiesa.
D’altro canto, il Concilio Vaticano II non era soltanto legato alla tradizione, ma, volendo essere ed essendo un Concilio della riforma, era anche aperto al presente e al futuro. La continuità con la tradizione fu quindi realizzata dal Concilio in modo innovativo, combinando la tradizione della Chiesa con un’interpretazione attualizzante nella nuova situazione storica in cui la Chiesa si trovava. Di questo compito faceva parte anche la sfida per la Chiesa di definire e sviluppare in modo nuovo il suo rapporto con il cosiddetto mondo e, in particolare, con la modernità. Per sviluppare la novità, mantenendo la continuità, il Concilio si è prefisso di rinnovare l’unico soggetto “Chiesa”: la Chiesa “è un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in cammino.”[19]
4. Diverse idee di riforma: ressourcement e aggiornamento
Le due ermeneutiche conciliari si sono diffuse soprattutto nel periodo postconciliare. Ciò si evince anche dal fatto che esse trovarono espressione nella fondazione di due riviste teologiche dai nomi che contraddistinguono tali ermeneutiche, ossia “Concilium”, come portavoce dell’ermeneutica della discontinuità e della rottura, e “Communio”, impegnata nell’ermeneutica della riforma. George Weigel descrive quindi la situazione post-conciliare della Chiesa cattolica come uno “scisma Concilium-Communio”[20].
Per comprendere meglio la situazione di tensione del periodo postconciliare, vale la pena gettare uno sguardo anche al periodo preconciliare, in cui si era già accesa una disputa appassionata sulla corretta visione e direzione dell’imminente Concilio, o, più precisamente, un dibattito su come dovesse essere intesa la riforma della Chiesa che ci si aspettava dal Concilio. Le varie correnti già presenti nel periodo di preparazione del Concilio condividevano senza dubbio la convinzione che la Chiesa fosse sempre bisognosa di rinnovamento. Nella realizzazione di questo obiettivo, tuttavia, esistevano due direzioni molto diverse; va dunque preso atto della controversia allora in atto tra i rappresentanti di diverse idee di riforma.
Nel contesto più ampio dei vari movimenti di rinnovamento che sorsero nella Chiesa cattolica dopo la prima guerra mondiale, come quello biblico, liturgico ed ecumenico, vi erano correnti che auspicavano un profondo rinnovamento della Chiesa attraverso il cosiddetto ressourcement, cioè la rivitalizzazione delle fonti della fede. Le fonti che si volevano far fluire in modo nuovo si trovavano principalmente nell’incontro con la Sacra Scrittura. Approfondendo la Sacra Scrittura, però, furono riscoperti anche i Padri della Chiesa, che erano innanzitutto esegeti della Sacra Scrittura e rappresentavano quindi la prima risposta della Chiesa alla parola del Vangelo, nel senso che “la Scrittura e i Padri sono inscindibilmente legati, come lo sono la parola e la risposta”[21]. In tal modo, si voleva favorire un aggiornamento nel senso di un autentico dialogo con il mondo moderno.
Tale programma di aggiornamento non mirava a un frettoloso e superficiale adeguamento della fede e della Chiesa alle plausibilità del mondo moderno. Queste correnti si prefiggevano piuttosto di annunciare, aggiornare e interpretare la fede cristiana in modo nuovo in un mondo profondamente cambiato. La parola chiave “aggiornamento” era quindi strettamente legata all’altra parola chiave “ressourcement”, nella convinzione che entrambe si esigessero e si promuovessero a vicenda e che l’aggiornamento potesse portare a un rinnovamento veramente intelligente e soprattutto cattolico della Chiesa solo se combinato al ressourcement.
Prima del Concilio, tuttavia, era attiva anche un’altra corrente di riforma, che poneva al centro esclusivamente l’aggiornamento, senza lasciare spazio al ressourcement. In queste correnti, l’attenzione era talmente concentrata sulle sfide del presente che un rinnovato ritorno ai Padri della Chiesa nel senso del ressourcement veniva percepito come una visita al museo preistorico o, nel migliore dei casi, come una sorta di velleità romantica. Di conseguenza, si puntava a una riforma della Chiesa basandosi soltanto sul legame tra Sacre Scritture e aggiornamento, e saltando completamente il riferimento al tempo dei Padri della Chiesa, senza quindi ricorrere al ressourcement originario. Tuttavia, questa corrente di riforma quasi mai contribuì all’attualizzazione della fede; piuttosto promosse un forte conformarsi della fede allo spirito del presente, come nota giustamente il teologo domenicano Aidan Nichols: “L’unità del duplice imperativo conciliare di ressourcement e aggiornamento, fondato come era sull’antropologia teologica dei Padri, si rivelò più fragile del previsto. Una volta che l’aggiornamento si separò dal ressourcement, l’adeguamento degenerò in un mero adattamento alle abitudini mentali e comportamentali della cultura secolare.”[22]
5. La fede, nella sua fedeltà alle origini e nel suo stare al passo coi tempi
Entrambe le correnti riformatrici erano presenti prima e durante il Concilio, ma la seconda acquisì maggior peso soprattutto dopo il Concilio, e fu considerata da gran parte dell’opinione pubblica come la fedele custode del Concilio. A distanza di quasi sessant’anni, tuttavia, è opportuno chiedersi ancora una volta come il Concilio si sia autoconcepito tra ressourcement e aggiornamento e quindi tra fedeltà alle origini e contemporaneità. Il rapporto tra queste due dimensioni, fondamentale, contraddistingue la Chiesa da sempre, ma la tensione si è acuita, in modo nuovo, dopo il Concilio Vaticano II.
Se l’accento viene posto esclusivamente sull’aggiornamento, vi è il pericolo che l’apertura della Chiesa al mondo, voluta e realizzata dal Concilio, si trasformi in un frettoloso adattamento dei fondamenti della fede allo spirito del tempo moderno. Non poche correnti nel periodo postconciliare si sono talmente orientate verso il mondo da non rendersi conto dei tentacoli dello spirito moderno, o da sottovalutarne l’impatto, cosicché la cosiddetta conversione al mondo non ha fatto sì che il lievito del Vangelo pervadesse maggiormente la società moderna, ma ha condotto piuttosto, nella Chiesa, a un conformismo di vasta portata con il mondo. Altrettanto incompatibili con l’apertura al mondo voluta dal Concilio sono però un allontanamento dal mondo, riscontrabile anche oggi, e un conseguente ripiegarsi della Chiesa su se stessa. Nella sua omelia in occasione del 60° anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II, Papa Francesco ha sottolineato questa duplice tentazione in modo incisivo: “sia il progressismo che si accoda al mondo, sia il tradizionalismo – o l’ “indietrismo” – che rimpiange un mondo passato, non sono prove d’amore, ma di infedeltà.”[23]
Ciò che è necessario oggi nello spirito del Concilio Vaticano II è il recupero di un sano equilibrio nel rapporto tra fede e Chiesa da un lato e mondo dall’altro, un equilibrio che può essere espresso nella formula elaborata dalla tradizione della Chiesa per la confessione cristologica, riguardo alle due nature di Cristo: Chiesa e mondo devono stare l’una di fronte all’altro in un rapporto “non mescolato, non alterato, non diviso e non separato”[24]. L’enfasi posta su “non mescolato” e “non alterato” suggerisce che il necessario contatto dialogico tra la Chiesa e il mondo contemporaneo non deve far sì che la fede e la Chiesa si adattino al mondo in modo secolarista, rinunciando pericolosamente alla loro identità. E l’accento messo su “non diviso” e “non separato” richiama all’attenzione il fatto che l’identità originaria della fede e della Chiesa non deve essere definita in modo tale da essere separata dal mondo in modo fondamentalista.
Al di là del conformismo secolarista e del fondamentalismo separatista, occorre che cerchiamo una terza via nel credere[25] mostrataci già dal Concilio. Per il Concilio, la fedeltà alle origini e la conformità ai tempi non erano contrapposte. Piuttosto, il Concilio voleva proclamare la fede cattolica in un modo che fosse insieme fedele alle sue origini e in linea con i tempi, per poter trasmettere la verità e la bellezza della fede agli uomini di oggi affinché possano comprenderla e accoglierla come un aiuto per la loro vita. Il Concilio non ha quindi generato una nuova Chiesa in rottura con la tradizione, né ha concepito una fede diversa, ma ha piuttosto mirato a un rinnovamento della fede e a una Chiesa rinnovata a partire dallo spirito del messaggio cristiano che è stato rivelato una volta per tutte e trasmesso nella tradizione viva della Chiesa.
In questo senso, il Vaticano II è stato un Concilio della riforma. Infatti, la riforma non può volere che ciò che viene riformato sia altro da ciò che deve essere riformato; altrimenti non si tratterebbe di una riforma, ma di un cambiamento di essenza che trasformerebbe ciò che va riformato in qualcosa di diverso da ciò che era prima. Piuttosto, la parola “riforma” nel suo senso originario indica che una realtà, dopo aver perso la sua forma ed essere stata deformata nel tempo, viene riportata alla sua natura originaria e quindi essenziale, attraverso un vero rinnovamento.
Il teologo francescano medievale Bonaventura ha illustrato in cosa consiste essenzialmente una riforma paragonandola all’arte dello scultore. Questa inizia con il fatto che lo scultore percepisce già l’immagine pura che aspetta, per così dire, di essere portata alla luce, liberata, nella pietra che ha davanti e che si accinge a scolpire artisticamente. In questo senso, l’attività artistica consiste nell’“ablatio”, nella rimozione dell’inautentico, affinché la “forma nobilis” possa riemergere[26]. Se, con Bonaventura, vedremo in questo processo artistico anche il modello originario della sempre necessaria riforma della Chiesa, allora capiremo che anche tale riforma potrà realizzarsi solo attraverso l’ablatio, attraverso il processo di purificazione della Chiesa basata sulle sue origini affinché la sua forma nobilis, la forma dell’unica Chiesa voluta da Cristo, possa tornare ad essere visibile.
Un’autentica riforma della Chiesa implica il recupero e il ripristino della vera forma della Chiesa. Aiutare la Chiesa affinché riesca a realizzare tale riforma sulla base della fede e nello spirito del Concilio Vaticano II è un servizio essenziale che la teologia può offrire. E se lo fa, sarà per il suo onore: “theologia honoris causa”.
[1] J. Ratzinger – Benedikt XVI., Zum Kirchenbild des Zweiten Vatikanums, in: Ders., Gottes Projekt. Nachdenken über Schöpfung und Kirche (Regensburg 2009) 93-116, zit. 102.
[2] Zukunft aus der Kraft des Konzils. Die ausserordentliche Bischofssynode ´85. Die Dokumente mit einem Kommentar von W. Kasper (Freiburg i. Br. 1986) 61.
[3] O. H. Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte – Verlauf – Ergebnisse – Nachgeschichte (Würzburg 1993) 105.
[4] Giovanni Paolo II, Vicesimus Quintus Annus, n. 2 e 4.
[5] Vgl. Ch. Schönborn, Leben für die Kirche. Die Fastenexerzitien des Papstes (Freiburg i. Br. 1997).
[6] C. M. Martini, Die Bischofssynode über das Wort Gottes, in: Stimmen der Zeit 133 (2008) 291-296, zit. 291.
[7] Dei Verbum, n.1.
[8] H. de Lubac, Die göttliche Offenbarung. Kommentar zum Vorwort und zum Ersten Kapitel der Dogmatischen Konstitution „Dei verbum“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (Einsiedeln 2001) 251.
[9] Gaudium et Spes, n. 40.
[10] Benedetto XVI, Discorso durante l’incontro con i parroci e il clero della diocesi di Roma, il 14 febbraio 2013.
[11] Ench. Vat. Vol I Documenti del Concilio Vaticano II, 104f.
[12] Vgl. K. Kardinal Koch, Auf dem Weg zu einer ökumenischen Feier des 1700. Jahrestags des Konzils von Nicaea (325 – 2023), in: P. Knauer, A. Riedl, D. W. Winkler (Hrsg.), Patrologie und Ökumene. Theresia Hainthaler zum 75. Geburtstag (Freiburg i. Br. 2022) 320-341.
[13] Vgl. K. Kardinal Koch, Theologe und Papst des Konzils. Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. und das Zweite Vatikanische Konzil, in: Ders., Bund zwischen Liebe und Vernunft. Das theologische Erbe von Papst Benedikt XVI. (Freiburg i. Br. 2016) 54-93.
[14] Benedetto XVI. Discorso al Collegio cardinalizio e ai membri della Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi del 22 dicembre 2005. Si veda anche Papst Benedikt XVI. und sein Schülerkreis – Kurt Kardinal Koch, Das Zweite Vatikanische Konzil. Die Hermeneutik der Reform (Augsburg 2012).
[15] H. Küng, Umstrittene Wahrheit. Erinnerungen (München 2007) 42.
[16] Benedetto XVI, Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica riguardo alla remissione della scomunica dei quattro vescovi consacrati dall’Arcivescovo Lefebvre (10 marzo 2009).
[17] Benedikt XVI., Vorwort, in: J. Ratzinger, Zur Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils = Gesammelte Schriften. Band 7/1 (Freiburg i. Br. 2012) 5-9, zit. 9.
[18] Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti del convegno promosso dal Pontificio Ateneo Sant’Anselmo nel 50.mo anniversario di fondazione, il 6 maggio 2011.
[19] Benedetto XVI, Discorso al Collegio Cardinalizio e ai membri della Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, il 22 dicembre 2005.
[20] G. Weigel, Das Projekt Benedikt. Der neue Papst und die globale Perspektive der katholischen Kirche (München 2006) 197.
[21] J. Kardinal Ratzinger, Die Bedeutung der Väter im Aufbau des Glaubens, in: Ders., Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie (München 1982) 139-159, zit. 152.
[22] A. Nichols, The Thought of Pope Benedict XVI. An Introduction to the Theology of Joseph Ratzinger (London 2007) 197.
[23] Francesco, Omelia per la Santa Messa in occasione del 60° anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II, l’11 ottobre 2022.
[24] J. Neuner / H. Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung (Regensburg 1971) Nr. 178.
[25] Vgl. K. Koch, Der dritte Weg zu glauben. Grundzüge eines öffentlichen Christentums, in: Geist und Leben 82 (2009) 20-37. Vgl. ferner A. Müller, Der dritte Weg zu glauben. Christsein zwischen Rückzug und Auszug (Mainz 1990).
[26] Bonaventura, Coll. In Hex. II, 33.