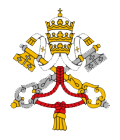EGUAGLIANZA E PARTECIPAZIONE NEL DIALOGO ECUMENICO
Conferenza all’Almo Collegio Capranica a Roma, il 3 dicembre 2019
Kurt Cardinale Koch
1. Eguaglianza e giustizia
Il termine e il contenuto di “eguaglianza” possono sembrare di facile comprensione a prima vista. Si tratta di una parola alquanto amata oggi e pronunciata spesso, una parola che, dai tempi della rivoluzione francese con il suo slogan “libertà, uguaglianza, fraternità”, è diventata un programma imprescindibile nella vita delle persone. È giusto che ciò avvenga se pensiamo, ad esempio, alla convinzione fondamentale che guida uno Stato di diritto democratico, secondo il principio che tutti devono essere uguali davanti alla legge. È infatti ingiusto che gli esseri umani, aventi pari dignità per natura, vengano trattati in maniera diversa. Questa è una convinzione di base assolutamente importante nelle società moderne. Naturalmente, se ne deve ricordare anche un’altra, secondo cui è ingiusto trattare le persone che sono diverse nel loro genere e nel loro status sociale come se fossero uguali. È allora grande il pericolo di uniformare ciò che è diverso.
a) Conoscenza tramite la corrispondenza o tramite il contrasto?
Questo semplice esempio mostra che esistono diverse forme di giustizia. La forma di giustizia per noi più ovvia si basa sul principio “a ciascuno spetta lo stesso che agli altri” . Ma c’è un’altra forma di giustizia ispirata al principio “a ciascuno il suo”. Per capire la differenza tra queste due forme, è bene riprendere la parabola di Gesù sui lavoratori della vigna (Mt 20, 1-16). Nella parabola, i lavoratori iniziano a lavorare a ore diverse del giorno e, di conseguenza, la quantità di lavoro prestato è disuguale, eppure tutti ricevono la stessa retribuzione. In questa situazione, è comprensibile considerare a prima vista l’atteggiamento del proprietario della vigna come ingiusto. Istintivamente, abbiamo l’impressione che sia ingiusta la non corrispondenza tra salario e tempo lavorato. E ancora più scandalosa ci pare la giustificazione data dal proprietario della vigna per il suo comportamento: tutti ottengono la stessa paga, perché il proprietario della vigna è buono. La differenza tra queste due forme di giustizia si delinea in maniera ancora più chiara quando riflettiamo sul fatto che, alla sua base, vi sono due diversi modi di conoscere la realtà.
“Chi si somiglia si piglia”: questo famoso e popolare principio comunitario, alla cui origine vi è addirittura il filosofo greco Aristotele, rispecchia il principio gnoseologico secondo cui l’oggetto della conoscenza può essere riconosciuto solo da chi è simile ad esso. Questo modello cognitivo conforme al principio della corrispondenza cerca in definitiva nell’altro solo la propria identità, come in una casa degli specchi. In questo senso, pensando ad esempio alla cosiddetta “scoperta” dell’America nel 1492, ci dovremmo chiedere se i colonizzatori europei abbiano davvero “scoperto” l’America o non abbiano piuttosto riscoperto la loro Europa in America. Tzvetan Todorov, nel suo saggio “La conquista dell’America. Il problema dell’altro”, ha voluto provare che l’America nella sua alterità e peculiarità in realtà non è mai stata “scoperta” dagli europei. Piuttosto, i conquistadores hanno “scoperto” in America ciò che essi da sempre cercavano, ovvero l’argento e l’oro. E persino gli imperi indiani nativi non sono mai stati realmente conosciuti e riconosciuti nella loro specificità; essi furono infatti colonizzati secondo il criterio europeo, e dovettero adattarsi ai sovrani, essendo considerati soggetti.[1]
Questo esempio storico suggerisce che la conoscenza secondo il modello della corrispondenza avviene sempre come un tentativo di dominio sull’altro, prevalendo in questo caso, nell’incontro con l’altro, la volontà di supremazia. Sia il principio comunitario “chi si somiglia si piglia”, sia il principio gnoseologico della conoscenza solo in virtù della somiglianza si rivelano embrioni di intolleranza. Il motivo principale della vera tolleranza sta infatti nella conoscenza degli altri secondo il modello del contrasto, che serve al riconoscimento dell’altro proprio nella sua alterità. Solo la conoscenza dell’altro nella sua alterità conduce a una comunione nella diversità, che determina e comporta anche il cambiamento del proprio punto di vista.
Questo principio cognitivo tollerante vale già a livello di percezione sensoriale. Già il filosofo greco Anassagora faceva osservare che essa nasce solo dal contrasto: avvertiamo il freddo partendo dal caldo, il dolce dall’amaro, la luminosità dall’oscurità. Ad esempio, sentiamo il calore del fuoco solo quando fa freddo intorno ad esso. La luminosità della luce è percepita solo quando è buio. Solo se ci troviamo in paesi stranieri capiamo cosa è la patria. E solo nel conflitto iniziamo ad apprezzare la pace. Il fatto che noi esseri umani siamo in grado di riconoscere quello che ci è proprio solo nel contrasto con l’altro e di sperimentare la nostra stessa identità solo relazionandoci all’altro è riassunto anche nel proverbio tedesco che dice: “Chi conosce solo l’Inghilterra non conosce l’Inghilterra”. Possiamo davvero conoscere l’Inghilterra solo se conosciamo altri paesi. Questo proverbio potrebbe essere declinato in molti modi: chi conosce solo il proprio sesso non lo conosce ancora. Chi conosce solo la propria nazione non la conosce ancora. Chi conosce solo la sua fede, non la conosce ancora.
Con il filosofo Anassagora dobbiamo andare ancora più a fondo. Egli evidenzia un legame cruciale tra la conoscenza secondo il modello del contrasto e l’esperienza umana del dolore: “La percezione sensoriale è legata al dolore. Quando ciò che è diverso entra in contatto con i nostri organi di senso, insorge il dolore.” Ciò che è vero a livello della percezione sensoriale, vale anche, ed in modo più determinante, in tutte le esperienze della vita umana. Infatti, davvero aperti a ciò che è nuovo e davvero sensibili nei confronti della specificità dell’altro noi umani lo diventiamo non attraverso la reciproca corrispondenza, ma attraverso la differenza, il contrasto, il contrario; e ciò non avviene, di solito, in maniera indolore. Su questo aspetto d’altronde la lingua greca attira l’attenzione, quando in vari proverbi fa rimare la parola “mathein” (= imparare) con “pathein” (= soffrire). In effetti, noi esseri umani possiamo davvero entrare in contatto con gli altri e capirli solo se ci sintonizziamo su di essi e cambiamo noi stessi, in un processo probabilmente doloroso, come ha sottolineato il teologo riformato Jürgen Moltmann: “Nella mia conoscenza dall’altro, mi sottometto alle sofferenze e alle gioie del mio stesso cambiamento, non per adeguarmi all’altro, ma per entrare in profonda sintonia con l’altro.”[2]
b) Lo straniero come nemico o come ospite?
Affinché queste riflessioni non paiano astratte, vorrei spiegare con un esempio concreto la differenza tra conoscenza attraverso la corrispondenza e conoscenza attraverso il contrasto, riferendomi al modo in cui percepiamo uno straniero. Questo modo è alquanto diverso nelle varie culture.
Nel latino preclassico, il termine “hostis” indica lo straniero e allo stesso tempo il nemico. Questo uso suggerisce che in quasi tutte le culture primitive lo straniero era inizialmente percepito come un nemico, più precisamente come colui che dall’esterno, e quindi in maniera sorprendente, irrompe nello spazio vitale altrimenti controllabile e lo mette in crisi per il semplice fatto di presentarsi in modo diverso rispetto ai “nativi”: con abiti diversi, con un colore di pelle diverso e con una lingua diversa. Non è dunque un caso che nelle culture primitive fosse pratica comune distruggere spietatamente lo straniero, che veniva definito nemico.
Sullo sfondo di questa memoria storica, è evidente che la proverbiale tradizione antica e soprattutto biblica dell’ospitalità costituisca una nuova cultura del rapporto con lo straniero. Non è un caso che in queste culture si sia potuta sviluppare una legge sull’ospitalità e che presso i Greci il termine “xenos” non designi più lo straniero e insieme il nemico, ma indichi lo straniero e insieme l’ospite. Soprattutto nella tradizione giudeo-cristiana, la pratica dell’ospitalità si rivela essere “l’antidoto biblico al nostro istinto di paura davanti allo straniero”.[3] Superando questi sentimenti arcaici e aprendo allo straniero non solo la porta di casa, ma anche la porta del cuore, l’ospitalità tenta di rendere lo straniero amico. Già il Talmud propone una definizione nuova e molto bella dello straniero, sottolineando che in realtà non ci sono stranieri, ma solo persone che non si sono ancora incontrate davvero. Ciò significa che, nel profondo, ogni essere umano è un potenziale amico, a condizione che si abbia il coraggio di aprirsi a lui e di accoglierlo nella sua alterità voluta da Dio. Allora, smette automaticamente di essere un estraneo e si trasforma in un ospite-amico.
c) Eguaglianza e diversità in Dio
Il fatto di considerare lo straniero come un nemico (hostis) o come un ospite (xenos) dipende da quale approccio cognitivo abbiamo, ovvero se conosciamo tramite la corrispondenza o tramite il contrasto. È solo con quest’ultimo tipo di conoscenza che possiamo percepire le persone come diverse ma aventi pari dignità. Ciò che vale per la percezione degli uomini, vale a priori anche per la conoscenza di Dio, che nella rivelazione cristiana ha mostrato la sua trinità, come un essere in tre diverse Persone. Il Dio uno e trino è in se stesso un eterno dialogo amoroso tra Persone diverse ma di pari dignità. Su questo mistero dobbiamo riflettere ancora un po’.
La fede cristiana nel Dio uno e trino confessa da un lato che in Dio stesso vi è spazio vitale per l’altro. Il Padre infatti è diverso dal Figlio e il Figlio è diverso dallo Spirito. Nella Trinità divina vive una diversità di Persone originaria e magnifica. Per questo la Chiesa cristiana ha condannato quale eresia il modalismo, secondo cui l’unica natura divina si manifesta in tre modi diversi. Se Dio in se stesso è differenza nella diversità delle Persone, allora egli è anche innamorato della differenza tra gli esseri umani, e qualsiasi uniformità o tendenza all’intolleranza nel rapporto tra gli uomini gli è fondamentalmente aliena. Dio ha creato l’essere umano nella dualità di uomo e donna, che insieme sono l’immagine di Dio nel mondo, come si legge nel primo racconto della creazione: “E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò” (Gen 1,27).
Dall’altro lato, la differenza di Persone nella Trinità divina non comporta nessun primato e nessuna subordinazione. Padre, Figlio e Spirito, a livello dell’essere, sono uguali e hanno pari dignità. Vi è in Dio un’originaria e magnifica unità ed eguaglianza di divinità nell’essenza delle tre Persone. La Chiesa cristiana ha infatti dichiarato eresia il subordinazionismo, secondo il quale il Figlio e lo Spirito sono gerarchicamente subordinati alla monarchia del Padre. Se Dio è in sé una comunione vivente di Persone senza primato e senza subordinazione, allora egli è anche innamorato della comunione tra gli esseri umani, e quindi ogni tendenza all’isolamento separatista tra le persone gli è fondamentalmente estranea.
Il Dio rivelato nella fede cristiana è dunque, sin dall’origine, sia unità che diversità, communio e differenza. Se gli esseri umani comprendono se stessi come immagine della Trinità divina, cercheranno di vivere anche questi due aspetti co-presenti sin dall’origine. Se infatti Dio stesso, come mistero del mondo, è dialogo amorevole, allora noi esseri umani sulla terra possiamo essere immagine di Dio solo se siamo persone di dialogo. E se Dio è sin dall’origine unità e diversità, anche noi siamo invitati a non negare le differenze, ma a percepirle in maniera positiva.
2. Unità e diversità nel dialogo ecumenico
Ciò che vale per ogni dialogo interpersonale, vale in modo particolare per il dialogo ecumenico e per la sua ricerca di ricomposizione dell’unità perduta. L’unità che cerchiamo non può essere infatti uniformità. Dato che l’unità è sempre un dono dello Spirito Santo, essa può essere solo un’unità nella diversità riconciliata. Lo Spirito Santo conduce sempre all’unità solo nella diversità. Contrariamente a noi esseri umani, sempre propensi, da un lato, a favorire la molteplicità e la diversità, chiudendoci nel particolarismo e nell’esclusivismo e creando divisioni e, dall’altro, inclini a determinare l’unità secondo le nostre idee umane, fino a giungere ad un’uniformizzazione unificante, lo Spirito Santo è il solo in grado di produrre pluralità e diversità e, allo stesso tempo, di operare l’unità. Lo Spirito Santo dona l’unità nella diversità.[4]
a) L’unità del battesimo e lo scambio di doni
L’unità donataci dallo Spirito Santo ci è già stata data nel battesimo. Il battesimo e il suo reciproco riconoscimento sono il fondamento di ogni sforzo ecumenico; l’ecumenismo cristiano è essenzialmente un ecumenismo battesimale. Questa costatazione di base costituisce il punto di partenza del decreto sull’ecumenismo “Unitatis redintegratio”. Già nel primo capitolo sui “Principi cattolici sull’ecumenismo”, viene ravvisato nel battesimo il motivo dell’appartenenza di tutti i cristiani alla Chiesa: “Coloro infatti che credono in Cristo ed hanno ricevuto validamente il battesimo, sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa cattolica.”[5] Il terzo capitolo su “Chiese e Comunità ecclesiali separate dalla Sede Apostolica Romana” trae significative conseguenze, sottolineando l’importanza del battesimo ed affermando che con esso, quando secondo l’istituzione del Signore è debitamente conferito e ricevuto con le disposizioni interiori richieste, l’uomo è veramente incorporato a Cristo crocifisso e glorificato, e viene rigenerato per partecipare alla vita divina. Si sottolinea quindi che il battesimo stabilisce un “vincolo sacramentale dell’unità” che vige tra tutti coloro “che per mezzo di esso sono stati rigenerati”[6].
Secondo la visione cattolica, il comune vincolo sacramentale del battesimo garantisce una comunione di fondo, seppure imperfetta. Il battesimo è “soltanto l’inizio e l’esordio”, perché “tende interamente all’acquisto della pienezza della vita in Cristo” e, pertanto, è “ordinato all’integra professione della fede, all’integrale incorporazione nell’istituzione della salvezza, quale Cristo l’ha voluta, e infine alla piena inserzione nella comunità eucaristica”[7]. Mentre il battesimo è l’inizio e l’esordio della vita cristiana e della comunità ecclesiale, l’Eucaristia ne rappresenta la pienezza e il culmine.
Il battesimo è il principio dell’unità e quindi la porta d’ingresso dell’ecumenismo. Diversamente, la pluralità e la diversità si fondano sull’essenza più intima del dialogo ecumenico, che non è semplicemente uno scambio di idee, di pensieri e di teorie, ma è un arricchente scambio di doni. Dietro questo vi è la convinzione che nessuna Chiesa o Comunità ecclesiale sia tanto ricca da non aver bisogno di essere arricchita da altre Chiese, e anche che nessuna Comunità ecclesiale sia tanto povera da non poter apportare il proprio contributo alla più ampia comunità di fede cristiana.
b) Il consenso differenziante
È importante che i vari doni arricchiscano l’unità fondamentale già raggiunta nel dialogo ecumenico e non rimettano in discussione il fatto che si tratti di un consenso differenziato. Questo riguarda il metodo che è stato ampiamente usato nei dialoghi ecumenici nel corso degli ultimi decenni. Naturalmente, sarebbe più adeguato parlare di un “consenso differenziante”, perché così verrebbe maggiormente messo in risalto il processo di approfondimento ecumenico del consenso che è stato già raggiunto. Questo metodo ecumenico sta a significare che il risultato di un dialogo ecumenico non è ancora un consenso totale, ma un consenso su questioni fondamentali. Tale consenso comprende la costatazione che esistono questioni ancora irrisolte, sulle quali ulteriori dialoghi ecumenici possono e devono essere tenuti, ma anche che le questioni in sospeso non rimettono in discussione né annullano il consenso di fondo conseguito. Inoltre, secondo questo consenso su questioni fondamentali, le differenze che permangono, espresse nella terminologia tradizionale e nelle formule confessionali, non sono più considerate come fonte di divisione, ma come divergenze che vanno riconciliate.
In cosa consista un consenso differenziante è illustrato nella maniera più chiara da una dichiarazione congiunta, che ha segnato una tappa importante nel dialogo tra la Chiesa cattolica e le Chiese della Riforma. Il primo dialogo avviato dalla Chiesa cattolica immediatamente dopo il Concilio fu quello con la Federazione Luterana Mondiale, un dialogo che si è dimostrato molto fruttuoso negli ultimi cinquant’anni. Un passo essenziale verso una maggiore comunione fu compiuto con la Dichiarazione Congiunta sulla Dottrina della Giustificazione, firmata ad Augusta il 31 ottobre 1999 dalla Federazione Luterana Mondiale e dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani. La dottrina della giustificazione del peccatore mediante la grazia divina rappresentava il fulcro della vita spirituale e dell’opera teologica di Martin Lutero, tanto che egli aderì ad esso con estrema perseveranza: a causa sua si giunse così alla Riforma e, in seguito, alla divisione nella Chiesa.
L’ecumenista protestante Wolfhart Pannenberg si è espresso su questa dottrina nel modo seguente: “Se questa dottrina venisse giudicata cattolica nella sua sostanza, allora cadrebbe il motivo decisivo, da essa originato, della divisione tra le Chiese della Riforma e la Chiesa cattolica romana. Una conferma ufficiale dell’ortodossia cattolica di questa dottrina di Lutero sarebbe quindi di grande rilevanza per la relazione tra le Chiese della Riforma e Roma.”[8] Ciò che Wolfhart Pannenberg aveva intuito in modo chiaroveggente già nel 1975 è diventato realtà con la Dichiarazione Congiunta del 1999. Dovremmo riconoscere come una pietra miliare ecumenica l’ampio consenso conseguito sulla questione centrale della fede che aveva diviso la Chiesa in Occidente nel XVI secolo. La sua importanza è ulteriormente evidenziata dal fatto che, nel frattempo, alla Dichiarazione Congiunta hanno aderito anche il Consiglio Metodista Mondiale nel 2006 e la Comunione Mondiale delle Chiese Riformate nel 2017, e nello stesso anno l’Arcivescovo di Canterbury, a nome della Comunione Anglicana Mondiale, ha approvato il documento, così che la Dichiarazione Congiunta sulla Dottrina della Giustificazione, da documento bilaterale, è diventata un documento multilaterale con cinque partner ecumenici firmatari.
Il consenso differenziante alla base della Dichiarazione Congiunta indica che non si tratta di un consenso totale, ma di un consenso su questioni fondamentali della dottrina della giustificazione; esso, ovviamente, non riguarda solo questa dottrina in senso stretto, ma si inscrive nel contesto generale del credo cristologico e trinitario della Chiesa indivisa dei primi secoli. Il consenso su questioni fondamentali della dottrina della giustificazione riconosce l’esistenza di questioni tuttora irrisolte nella dottrina della giustificazione su cui possono e devono essere tenuti ulteriori dialoghi ecumenici, ad esempio in merito al chiarimento del concetto “simul iustus et peccator” o alla questione di una possibile cooperazione dell’uomo al processo della salvezza; tali questioni irrisolte tuttavia non mettono in discussione, né tantomeno annullano, il consenso di base già raggiunto. Il consenso sottintende anche che le reciproche condanne dottrinali del XVI secolo relative alla dottrina della giustificazione non si applicano più ai partner ecumenici di oggi, se essi si attengono ai fondamenti della Dichiarazione Congiunta. In questo senso, è diventato possibile integrare le priorità delle varie confessioni, come l’enfasi luterana posta sulla sovranità della grazia di Dio e quella cattolica sull’efficacia di tale grazia, che consente all’uomo giustificato di compiere opere buone come frutti della giustificazione. Ma per comprendere meglio questo consenso di base, il passo successivo sarà capire qual è il contenuto esatto della dottrina della giustificazione.
c) Il primato dell’accogliere rispetto al fare
“Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto, perché te ne vanti come non l’avessi ricevuto?” (1 Cor 4,7). Con queste parole, l’Apostolo Paolo, davanti a colui che si gloria della sua prestazione, insiste sul fatto che l’uomo non deve considerare ciò che è e ciò che ha come il risultato del proprio agire, ma deve accoglierlo come un dono immeritato di Dio. Soprattutto per ciò che riguarda la propria salvezza, l’uomo non può e non deve fare affidamento sulle sue opere. Infatti, là dove è in gioco l’aspetto centrale e autentico della vita cristiana, la felicità e il successo, quello che conta non è il fare dell’uomo. La salvezza è concessa all’essere umano non in base alle sue opere e neppure in base a forme esteriori di pietà quali le indulgenze; queste, agli occhi dei riformatori, veicolano piuttosto l’ingannevole certezza di essere salvati, dando l’impressione che la propria salvezza possa essere acquistata da Dio. Quando si tratta della salvezza dell’essere umano, siamo piuttosto davanti a una passività dell’individuo che non può essere né taciuta né rimossa; l’individuo, cioè, deve aprirsi al dono non manipolabile di Dio nella sua grazia.
Essenzialmente, la dottrina della giustificazione per fede afferma che là dove si tratta della salvezza degli esseri umani, Dio stesso agisce su di essi; di conseguenza, non è l’uomo che ha bisogno di giustificarsi davanti a Dio, né d’altronde è in grado di farlo, ma è Dio che giustifica l’uomo, ovvero lo accoglie. L’uomo non deve compiere quest’azione o quest’altra, ma deve fare una cosa sola, in maniera costante: deve effettuare un passo fuori da se stesso e affidarsi completamente a un altro, ovvero a Dio. Il motivo della giustificazione non è ciò che l’uomo offre o fa, ma è la premura amorosa e misericordiosa di Dio per l’uomo. Giustificazione non significa conteggio di azioni e prestazioni realizzate dall’uomo, ma riconoscimento della grazia di Dio. È Dio che accetta l’uomo anche se inaccettabile e che lo giustifica, nonostante questa sua inaccettabilità. Da parte sua, l’uomo deve semplicemente accogliere quanto Dio compie: questo significa credere. La fede, nel senso di un fiducia totale in Dio, significa dunque, secondo la concisa definizione di Paul Tillich: “accettare il fatto che vengo accettato, nonostante io sia inaccettabile.”[9] Nella fede riconosco che davanti a Dio sono inaccettabile; nella fede, però, so anche che, nonostante questo, vengo accettato da Dio; e questo io posso accettarlo nella fede.
La dottrina della giustificazione trasmette il messaggio gioioso secondo cui l’essere umano non deve e non può da solo, basandosi sulle sue sole forze, giungere alla realizzazione del senso della propria vita, perché questa realizzazione avviene per dono divino. L’uomo, infatti, può avere la certezza di essere accolto da Dio in maniera definitiva nel suo essere uomo senza dover far niente e senza poter far niente al riguardo. Questa esperienza di essere riconosciuto e amato come individuo, indipendentemente dalle proprie prestazioni e, in alcune circostanze, nonostante le proprie prestazioni, o comunque in maniera distinta da esse, l’essere umano può farla soltanto nell’incontro personale con Dio. La fede cristiana nella giustificazione si rivela dunque avvocata della grazia nel mezzo della società odierna così tanto minacciata dalla mancanza di misericordia individuale e strutturale, una mancanza di misericordia che consiste nel fatto che l’uomo viene identificato con le proprie prestazioni e che, di conseguenza, non riconosce la dignità di coloro che non sono ancora in grado o non sono più in grado di offrire prestazioni.
Il grande beneficio umano recato dalla fede cristiana nella giustificazione consiste invece nella distinzione fondamentale e liberatrice che essa fa tra l’essere umano e le sue prestazioni. Nell’essere uomo dell’uomo, essa distingue infatti tra il suo essere-persona e il suo essere-agente.[10] Davanti a ogni agire, la fede cristiana nella giustificazione prende molto sul serio l’uomo come persona fondamentalmente distinta dalle sue azioni, una persona che diventa tale non per il suo agire, ma perché riceve se stessa da Dio. L’uomo inizia ad agire soltanto spinto dall’amore, che scaturisce dalla fede e che realizza buone opere quali frutti della giustificazione. Dal punto di vista soteriologico, da ciò deriva la conseguenza senz’altro più fondamentale, ovvero che la prestazione dell’uomo è un suo diritto, ma in nessun modo la sua giustificazione. L’uomo è qualcosa di infinitamente più grande rispetto alla somma delle sue azioni e soprattutto alla somma delle sue cattive azioni. Questo è il motivo per cui la pena di morte, solo per citare un esempio, è totalmente incompatibile con la dottrina della giustificazione. La pena di morte cancella infatti la distinzione cruciale tra essere-persona ed essere-agente e identifica completamente il crimine dell’uomo con la sua persona; e ciò denota una totale mancanza di misericordia.
La conseguenza della fede cristiana nella giustificazione è l’inversione radicale del rapporto, ormai consolidato nella vita quotidiana, tra essere e fare, tra persona e opera, tra grazia e prestazione: non è assolutamente la prestazione che fa dell’essere umano un essere umano; piuttosto, è l’essere umano che viene reso capace di compiere prestazioni. Non sono le opere che fanno una persona; è la persona che, creata e amata da Dio, da lui liberata e redenta, compie le opere. E non possiamo neppure dire che le opere buone fanno buone le persone; piuttosto, solo le buone persone sono capaci di compiere buone opere.
d) La collaborazione tra la grazia di Dio e la libertà dell’uomo
In ciò risiede il messaggio della fede biblica nella giustificazione, che al tempo della Riforma è stato rivalorizzato e che oggi possiamo professare in una comunione ecumenica. Questo messaggio afferma essenzialmente che noi uomini siamo tutti uguali davanti a Dio, ovvero siamo tutti dipendenti dalla sua salvezza. Nel dialogo ecumenico si tratta però di capire in maniera più approfondita quale sia la partecipazione dell’uomo all’evento della giustificazione: ci chiediamo, cioè, se l’uomo è semplicemente oggetto dell’opera salvifica di Dio, e se, di conseguenza, la fede cristiana nella giustificazione, in riferimento alla salvezza, non debba prevedere alcuna collaborazione da parte dell’uomo. Fu soprattutto Martin Lutero, tra i riformatori, a muoversi in questa direzione, nella disputa appassionata che egli ebbe con l’umanista Erasmo da Rotterdam e con la visione ottimista della libertà umana espressa nel suo “De libero arbitrio”. Rispondendo a ciò, Lutero si spinse sino a dire in “De servo arbitrio”, con una tagliente incisività difficilmente superabile, che l’uomo è come un animale da sella, cavalcato o da Dio o dal diavolo[11].
Davanti a queste sferzanti affermazioni ci dobbiamo chiedere seriamente se, alla luce della dottrina della giustificazione, si possa pensare che anche l’uomo, come soggetto della fede, collabori all’evento della giustificazione, e se e fino a che punto il battezzato, dopo che Dio ci ha apportato in dono l’inizio della salvezza, accolga questo dono solo passivamente oppure collabori, ovvero fino a che punto egli stesso, in virtù della nuova forza della grazia divina, possa operare e possa interagire, tramite le sue opere, con il giudizio finale di Dio. Con ciò tocchiamo senza dubbio il punto più sensibile e complesso del consenso differenziante sulla dottrina della giustificazione. A questa domanda, la teologia cattolica risponde in maniera positiva, come testimonia il Catechismo della Chiesa cattolica: “La giustificazione stabilisce la collaborazione tra la grazia di Dio e la libertà dell’uomo. Dalla parte dell’uomo essa si esprime nell’assenso della fede alla Parola di Dio che lo chiama alla conversione, e nella cooperazione della carità alla mozione dello Spirito Santo, che lo previene e lo custodisce.”[12]
Si capisce che la libertà dell’uomo di cui parla il Catechismo è la libertà a cui siamo pervenuti attraverso Cristo. In questo senso, anche la Dichiarazione Congiunta sulla Dottrina della Giustificazione sottolinea che i cattolici, quando affermano il “carattere meritorio” delle buone opere, intendono evidenziare “la responsabilità dell’uomo nei confronti delle sue azioni”, senza contestare con ciò “il carattere di dono delle buone opere, e tanto meno negare che la giustificazione stessa resta un dono immeritato della grazia”[13]. Diversamente, nella tradizione riformata, esistono affermazioni che sono state interpretate o che quantomeno potrebbero essere interpretate come risposte negative alle domande sopra menzionate. Ecco dunque che ci dobbiamo chiedere se sia possibile avere una visione ecumenica comune del rapporto tra la grazia di Dio e la libertà dell’uomo nell’evento salvifico, alla luce della fede nella giustificazione. Ancora più urgente sorge la domanda sul significato dell’onnipotenza divina: occorre chiedersi se l’agire-su tutto di Dio, secondo la nostra comune testimonianza, sottintenda anche il controverso agire-da solo di Dio, che comporterebbe una semplice passività da parte dell’uomo.[14]
Per trovare una risposta comune a questa domanda di grande importanza ecumenica, conviene immergersi nella testimonianza biblica di Dio. Tale testimonianza evidenzia che noi uomini riceviamo da Dio tutto ciò che siamo e tutto ciò che possiamo fare, e che l’agire umano non è commensurabile con quanto Dio ci dona. In ciò consiste il messaggio fondamentale della dottrina della giustificazione, nel senso che la giustizia non viene più intesa come un fare - come avveniva nella tradizione aristotelica secondo cui l’uomo diventa giusto se agisce giustamente -, ma come un “essere in virtù di Dio: il dono di Dio nella fede in Gesù Cristo”[15]. La testimonianza biblica di Dio contiene però anche il seguente messaggio: il Dio di cui parla la Bibbia vuole essere ed è un vero e proprio Dio della relazione e, per questo, chiama l’uomo a porsi davanti a lui in maniera personale, cosicché ciò che l’uomo è e ciò che l’uomo fa ha un peso reale, nonostante l’incommensurabilità tra uomo e Dio; e Dio invita l’uomo a collaborare alla sua opera: “Non siamo le marionette di Dio, alle quali non si chiederebbe né si permetterebbe di agire in maniera responsabile davanti a lui. La rinuncia alla responsabilità, alla capacità di dimostrarsi responsabili davanti a Dio sarebbe soltanto una redenzione apparente. Tale rinuncia in realtà ci degraderebbe, e degraderebbe così anche Dio. Ciò che siamo e ciò che facciamo conta per lui realmente.”[16]
e) Le conseguenze ecclesiologiche della giustificazione
Ecco allora che vengono alla luce anche gli aspetti ecumenici sui quali non è stato ancora trovato un consenso nella Dichiarazione Congiunta sulla Dottrina della Giustificazione. Questi riguardano innanzitutto la questione ecclesiologica della natura e della missione della Chiesa di Gesù Cristo ed in particolare la questione di stabilire “dove” la Chiesa è presente e sperimentabile concretamente. Il punto controverso è se il Dio uno e trino incontra noi uomini solo “nella” Chiesa o anche “attraverso” la Chiesa. Confessare che Dio opera “nella” Chiesa non dovrebbe essere problematico neppure per i cristiani della Riforma. Più difficile da accettare per loro è la professione secondo cui Dio opera anche “attraverso” la Chiesa concreta. Diversamente, la teologia cattolica intende la Chiesa come segno e strumento di salvezza o, come ha ricordato il Concilio Vaticano Secondo, come sacramento universale di salvezza. La questione della mediazione salvifica della Chiesa è quindi strettamente legata a quella della sua dimensione sacramentale.
La questione ecclesiologica si concentra in particolare sul tema del ministero ordinato, sul suo ruolo e sulla distinzione tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale. Dal punto di vista cattolico, il ministero sacerdotale, il ministero episcopale e il ministero petrino sono costitutivi dell’essere Chiesa della Chiesa e sono forme di mediazione ecclesiastico-istituzionale. Si capisce dunque che dietro la protesta della Riforma contro l’interpretazione cattolica del ministero ordinato vi è il sospetto che, tramite i ministeri ecclesiali, si vogliano collocare mediatori umani tra i singoli individui e Dio. In risposta a tali preoccupazioni e paure, la teologia cattolica considera l’opera salvifica di Dio all’interno di una visione sacramentale, secondo cui l’opera salvifica di Dio ci incontra sempre anche attraverso la mediazione di ciò che è umano-terreno ed ecclesiale. La questione del ministero ordinato è quindi giustamente considerata come un punto cruciale nell’attuale discussione ecumenica sull’ecclesiologia.
La questione dell’ecclesiologia e del ministero si basa su quella agiologica e mariologica, trattandosi di capire se, per quanto riguarda il dono della salvezza offerta esclusivamente da Gesù Cristo, una partecipazione intercessoria dei santi in generale e di Maria in particolare possa essere ritenuta compatibile con la dottrina della giustificazione. La fede cattolica risponde in maniera positiva a questa domanda e sostiene che la venerazione dei santi è una forma di adorazione di Dio, come espresso nel Prefazio dei santi: “Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria, e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia.” Nel venerare un santo, viene adorato quel Dio che ha realizzato il suo avvento nel santo e che dal santo è stato accolto. Vista in questa luce, l’invocazione rivolta ai santi non si contrappone in alcun modo alla mediazione esclusiva di Gesù Cristo; piuttosto, è l’espressione liturgica del fatto che i santi, anche in cielo dove intercedono per noi davanti a Dio, continuano a vivere il loro amore per il prossimo. Ciò che si può dire dei santi è vero in modo particolare nel caso di Maria, che Dio ha scelto come madre di suo Figlio, e la cui cooperazione alla storia della salvezza è stata resa possibile solo dalla grazia divina. Nella figura di Maria, quindi, incontriamo la dottrina della giustificazione “incarnata”, come sottolinea il documento ecumenico “Communio Sanctorum”: “secondo il pensiero cattolico, la madre di Cristo è l’incarnazione dell’evento della giustificazione per sola grazia e per fede”[17].
Le prospettive a cui si è brevemente accennato in merito alle questioni controverse e ancora aperte nella Dichiarazione Congiunta sulla Dottrina della Giustificazione non mettono in discussione il consenso raggiunto sulle questioni fondamentali di questa dottrina, ma richiedono un ulteriore approfondimento nei dialoghi ecumenici al fine di pervenire a una maggiore convergenza. Come si evince dall’espressione utilizzata nella Dichiarazione Congiunta che presenta un “consenso su verità fondamentali della dottrina della giustificazione”, non è stato ancora conseguito un pieno consenso su tale dottrina e, soprattutto, sulle sue conseguenze per l’ecclesiologia e per la questione del ministero ordinato. Poiché le questioni irrisolte riguardano una comprensione più precisa di ciò che è la Chiesa, le implicazioni ecclesiologiche del consenso finora raggiunto devono far parte dei principali punti all’ordine del giorno negli attuali dialoghi ecumenici. La loro elaborazione rappresenta un altro importante passo avanti sul cammino dell’intesa ecumenica, che, così ci auguriamo, potrebbe culminare nella preparazione di una futura Dichiarazione Congiunta analoga a quella sulla dottrina della giustificazione, questa volta su Chiesa, Eucaristia e ministero.[18]
Con gratitudine possiamo costatare che già diversi dialoghi ecumenici nazionali hanno affrontato questo tema[19]: il dialogo luterano-cattolico negli Stati Uniti ha presentato al riguardo una “Declaration on the Way: Church, Ministry, and Eucharist”[20]; e anche il dialogo nazionale in Finlandia ha pubblicato un’ampia presa di posizione intitolata “Communion in Growth” sullo stesso argomento[21]. Sarebbe uno sviluppo incoraggiante e un evento di forte valenza simbolica dal punto di vista ecumenico se si potesse raggiungere un ulteriore consenso su tali questioni. Ciò mostrerebbe in maniera ancora più chiara quanto l’eguaglianza e la partecipazione al dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica e le Chiese e le Comunità ecclesiali nate dalla Riforma siano inscindibilmente legate.
[1] T. Todorov, Die Eroberung Amerikas. Das Problem des Anderen (Frankfurt a. M. 1985).
[2] J. Moltmann, Die Entdeckung des Anderen. Zur Theorie des kommunikativen Erkennens, in: Evangelische Theologie 50 (1990) 400-414, zit. 409.
[3] P. Lapide, Können wir die Fremden lieben? (Mainz 1988) 69.
[4] Cfr. Francesco, omelia per la Santa Messa nella cattedrale cattolica dello Spirito Santo a Istanbul, il 29 novembre 2014.
[5] Unitatis redintegratio, n. 6.
[6] Unitatis redintegratio, n. 22.
[7] Ibid.
[8] W. Pannenberg, Reformation und Einheit der Kirche, in: Ders., Ethik und Ekklesiologie. Gesammelte Aufsätze (Göttingen 1977) 254-267, zit. 259.
[9] P. Tillich, Systematische Theologie. Band III (Stuttgart 1966) 254-258.
[10] Vgl. E. Jüngel, Der menschliche Mensch. Die Bedeutung der reformatorischen Unterscheidung der Person von ihren Werken für das Selbstverständnis des neuzeitlichen Menschen, in: Ders., Wertlose Wahrheit. Zur Identität und Relevanz des christlichen Glaubens. Theologische Erörterungen III (München 1990)194-213.
[11] M. Luther, WA 18, 635.
[12] Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1993.
[13] Dichiarazione Congiunta sulla dottrina della giustificazione, n. 38.
[14] Vgl. W. Kasper, Zum gegenwärtigen Stand des ökumenischen Gesprächs zwischen den reformatorischen Kirchen und der Katholischen Kirche, in: Ders., Wege zur Einheit der Christen = Gesammelte Schriften. Band 14 (Freiburg i. Br. 2012) 299-318, bes. 306-310. Vgl. auch K. Koch, Der Heidelberger Katechismus in katholischer Sicht heute, in: M. E. Hirzel, F. Mathwig, M. Zeindler (Hrsg.), Der Heidelberger Katechismus – ein reformierter Schlüsseltext = reformiert! Band 1 (Zürich 2013) 287-306.
[15] Ch. Schad, Rechtfertigung: Gottes Ja zu uns!, in: H. Schwier / H.-G. Ulrichs (Hrsg.), Nötig zu wissen. Heidelberger Beiträge zum Heidelberger Katechismus (Heidelberg 2012) 103-107, zit. 105.
[16] J. Cardinal Ratzinger, Wie weit trägt der Konsens über die Rechtfertigungslehre? in: IkaZ Communio 29 (2000) 424-437, zit. 433.
[17] Bilaterale Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, Communio Sanctorum. Die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen (Paderborn – Frankfurt a. M. 2000), Nr. 267.
[18] Vgl. K. Koch, Auf dem Weg zur Kirchengemeinschaft. Welche Chance hat eine gemeinsame Erklärung zu Kirche, Eucharistie und Amt? in: Catholica 69 (2015) 77-94.
[19] Vgl. auch B. Oberdorfer, Der Weg ist (nicht?) das Ziel. Was folgt auf die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“? in: Una Sancta 73 (2018) 227-241.
[20] Bishop´s Committee for Ecumenical and Interreligious Affairs – United States Conference of Catholic Bishops and Evangelical Lutheran Church in America, Declaration on the Way: Church, Ministry and Eucharist (Minneapolis 2015).
[21] Communion in Growth. Declaration on the Church, Eucharist and Ministry. A Report from the Lutheran-Catholic Dialogue Commission for Finland (Helsinki 2017).