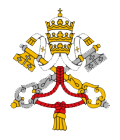DIALOGO PIONERISTICO
Rev.do P. Hyacinthe Destivelle, OP
Al momento della sua creazione, il 5 giugno 1960, il Segretariato per l’unità dei cristiani non era incaricato delle relazioni con le Chiese ortodosse. Esse erano affidate all’allora Congregazione per la Chiesa orientale, incaricata, dalla sua fondazione nel 1917, dei contatti con tutte le Chiese orientali, quelle in unione con Roma come quelle che non lo erano. Al nuovo Segretariato erano soprattutto affidati i rapporti con le comunioni cristiane occidentali e con il movimento ecumenico, del quale il Consiglio ecumenico delle Chiese, creato nel 1948 — seppur con la partecipazione delle Chiese ortodosse — si presentava come l’espressione istituzionale. Si dovrà aspettare tre anni dopo la sua creazione affinché, con una lettera del 14 gennaio 1963 del segretario di Stato, il nuovo Segretariato per l’unità dei cristiani sia ufficialmente incaricato anche delle relazioni con le Chiese ortodosse e che due sezioni siano create nel suo seno, una occidentale e una orientale.
In realtà, il Segretariato non aveva aspettato questa conferma per avviare nuovi contatti con le Chiese ortodosse, in particolare per invitarle ad inviare osservatori al concilio Vaticano II. Se la presenza di osservatori delle Chiese ortodosse di tradizione bizantina è ben conosciuta, è meno noto che le Chiese ortodosse orientali mandarono anche loro delegati al concilio dal suo inizio. Queste antiche Chiese d’oriente — copta, etiopica, siriaca, armene, malankaresi — nel passato impropriamente chiamate “monofisite” a causa del loro rifiuto delle formulazioni cristologiche del concilio di Calcedonia (451), riprendevano contatto con la Chiesa di Roma per la prima volta dal concilio di Firenze (1439).
Questi contatti ritrovati in occasione del concilio Vaticano II furono decisivi per lo sviluppo futuro delle relazioni, tanto più che alcuni tra gli osservatori ortodossi orientali diventeranno capi delle loro Chiese: Karekin Sarkissian, futuro catholicos armeno; Raamban Zakka Iwas, futuro patriarca siro ortodosso; Paulos Verghese, futuro catholicos della Chiesa ortodossa siriaca malankarese. Durante il suo viaggio a Gerusalemme nel 1964, san Paolo VI incontrò per la prima volta il capo di una Chiesa ortodossa orientale, il patriarca armeno Yegheshe Derderian. Il primo primate ortodosso a recarsi a Roma dopo il concilio — prima pure del patriarca di Costantinopoli Atenagora — fu anche un armeno: il catholicos Khoren 1 di Cilicia, che visitò Paolo VI nel maggio 1967. I patriarchi di tutte le Chiese ortodosse orientali si recarono in seguito a Roma negli anni Settanta: armeni, copti, etiopici, siriaci, malankaresi. Lo spirito di queste visite fu ben reso dal catholicos armeno Vasken di Etchmiadzin che incontrò per la prima volta Paolo VI nel 1970, e dichiarò che lui e il Papa «ricordavano, come in un risveglio, che siamo fratelli da duemila anni».
Grazie al dialogo non ufficiale promosso dalla fondazione austriaca Pro Oriente con le diverse Chiese ortodosse orientali, queste visite furono l’occasione per firmare dichiarazioni comuni (Dichiarazioni comuni di Paolo VI con il patriarca siro ortodosso Ignatius Jacob III (1971), con il papa copto ortodosso Shenouda III (1973); di Giovanni Paolo II con il patriarca siro ortodosso Ignazio Zakka i Iwas (1984), con il catholicos Mar Baselius Marthoma Mathews i della Chiesa ortodossa sira malankarese (1990), con il catholicos Karekin i della Chiesa ortodossa Armena di Etchmiadzin (1996), con il catholicos Aram i della Chiesa ortodossa armena di Cilicia (1997), e qualche volta per avviare anche commissioni bilaterali, in particolare con la Chiesa copta. Solo nel 2003 fu possibile istituire una commissione di dialogo internazionale con l’insieme delle Chiese ortodosse orientali. Sul tavolo del dialogo si trovano già una serie impressionante di studi, convergenze e accordi ufficiali, frutto di quasi cinquant’anni di ricerche e di conversazioni ecumeniche. Lo scopo di questo articolo non è di farne la cronologia o la sintesi, ma di mostrarne l’originalità da un punto di vista metodologico. Infatti, questo dialogo con le Chiese ortodosse orientali ha tre caratteristiche che ne fanno un dialogo pionieristico sul cammino ecumenico.
La prima caratteristica è la scelta, da subito, di una metodologia “ermeneutica” nel dialogo teologico, in particolare per le questioni cristologiche, principale controversia teologica tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse orientali, relativa alla comprensione del mistero di Cristo, perfettamente Figlio di Dio e perfettamente figlio dell’uomo. Il dialogo ha permesso di riconoscere che il contenzioso era dovuto essenzialmente a questioni terminologiche e di affermare che la stessa fede può essere espressa in modi diversi. Già nel 1971 Paolo VI e il patriarca siro ortodosso Mar Ignatius Jacoub III concordavano sul fatto che «non ci sono differenze nella fede che professano, riguardo al mistero della Parola di Dio, fatta carne e diventata veramente uomo, anche se, nel corso dei secoli, sono emerse difficoltà dalle diverse espressioni teologiche con cui questa fede è stata espressa».
Come spiega particolarmente bene la dichiarazione comune del 1990 di san Giovanni Paolo II e del catholicos Mar Baselios Mar Thoma Mathews i della Chiesa ortodossa sira malankarese: il contenuto della fede cristologica «è lo stesso», anche se «nella formulazione di questo contenuto nel corso della storia sono comparse differenze nella terminologia e nell’enfasi», tuttavia «queste differenze possono esistere nella stessa comunione e quindi non devono dividerci, specialmente quando proclamiamo [Dio] ai nostri fratelli e sorelle nel mondo in termini che possono comprendere più facilmente» (n. 8). Si può dire senza esagerazione che il dialogo con le Chiese ortodosse orientali fu pionieristico nell’applicare una metodologia “ermeneutica” che sarà più tardi chiamata del “consenso differenziato” nell’ambito del dialogo teologico tra cattolici e luterani (la Dichiarazione comune sulla dottrina della giustificazione (1999) tra la Chiesa cattolica e la Federazione luterana mondiale riconobbe l’esistenza di un consenso alla luce del quale «sono accettabili le differenze che sussistono per quanto riguarda il linguaggio, gli sviluppi teologici e le accentuazioni particolari» [n. 40]).
Una seconda caratteristica di questo dialogo è la sua dimensione pastorale. Il mutuo riconoscimento della successione apostolica e dei sacramenti ha permesso la firma di accordi pastorali senza precedenti, frutti del dialogo teologico. Nella loro dichiarazione congiunta del 1984, Papa Giovanni Paolo II e il patriarca siro ortodosso Zakka i Iwas hanno autorizzato i loro fedeli persino a ricevere i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione dei malati nell’altra Chiesa, quando l’accesso a uno dei loro sacerdoti fosse stato impossibile. Per la Chiesa cattolica, si trattava del primo accordo pastorale reciproco con un’altra Chiesa in tempi moderni.
Nel 1994 un importante accordo sui matrimoni misti fu firmato tra la Chiesa cattolica e la Chiesa siro-ortodossa malankarese, riconoscendo ad ambedue le parti delle coppie miste non solo il diritto di rimanere nella Chiesa del proprio battesimo, ma anche la possibilità di ricevere in certe circostanze la comunione nella Chiesa del consorte. Con la Chiesa assira d’oriente, il riconoscimento dell’anafora di Addai e Mari, che non include esplicite parole dell’istituzione, ha permesso nel 2001 un accordo permettendo una certa communicatio in sacris tra la Chiesa caldea e la Chiesa assira d’oriente. Questi accordi pastorali, che permettono già di «far partecipare ai mezzi della grazia» (Unitatis redintegratio, 8), nonostante le nostre Chiese non siano ancora in piena comunione, non hanno equivalenti nelle altre relazioni ecumeniche della Chiesa cattolica, sia in oriente che in occidente.
Una terza caratteristica di questo dialogo è la sua apertura a un modello ecclesiologico di ristabilimento dell’unità nel ministero apostolico che può essere chiamato “comunionale”. Infatti, eredi di Chiese nate prima dell’apparizione di una chiara gerarchia tra le diverse sedi e rimaste isolate fuori dall’impero bizantino, gli ortodossi orientali si percepiscono come una “famiglia” di Chiese, una famiglia in comunione di fede e di sacramenti, ma che non ha né un centro amministrativo né un primato anche solo simbolico. Questa situazione influisce anche sulla riflessione circa il modello di ristabilimento della piena comunione con la Chiesa cattolica. Già i «Principi per guidare la ricerca dell’unità tra la Chiesa cattolica e la Chiesa copta ortodossa», firmati nel 1979 da Papa Giovanni Paolo II e dal patriarca Shenouda III, affermavano: «L’unità che prevediamo in nessun modo significa assorbimento dell’uno dall’altro o dominio dell’uno sull’altro» ma «presuppone che le nostre Chiese continuino ad avere il diritto e il potere di governarsi secondo le proprie tradizioni e discipline».
Nel 2015 il secondo documento della commissione di dialogo con l’insieme delle Chiese ortodosse orientali mostrò che le espressioni di comunione tra le Chiese nei primi cinque secoli (scambio di lettere e di visite, sinodi e concili, preghiera comune e scambio di pratiche liturgiche, mutuo riconoscimento del martirio, del monachesimo, dei santi, eccetera) «erano informali, cioè non svolte all’interno di strutture chiare» e «tendevano ad attuarsi principalmente a livello regionale; non c’era un chiaro punto di riferimento centrale». Infatti, «da un lato, a Roma vi era una crescente consapevolezza di un ministero di più ampia comunione e unità, in particolare dalla fine del III secolo in poi; d’altra parte, non vi sono prove chiare che le Chiese ortodosse orientali abbiano mai accettato un simile ministero» (n. 71). Questa costatazione è un insegnamento importante nell’attuale ricerca della piena comunione con le Chiese ortodosse orientali, soprattutto se si tiene in mente il principio del Vaticano II che «per ristabilire o conservare la comunione e l’unità bisogna “non imporre altro peso fuorché le cose necessarie” (Atti degli apostoli, 15, 28) (n. 18). Anche qui il dialogo con le Chiese orientali è stato pionieristico nell’aprire la via a un modello di ristabilimento dell’unità che non sia giurisdizionale, ma comunionale.
Approccio ermeneutico, dimensione pastorale, modello comunionale: queste tre caratteristiche metodologiche del dialogo con le Chiese ortodosse orientali riguardano i tre livelli ai quali l’unità dei cristiani deve realizzarsi: nella fede, nei sacramenti e nel ministero. Grazie ai passi pionieristici compiuti in questi campi il ristabilimento della piena comunione con le Chiese ortodosse orientali non è una prospettiva irrealistica.
È vero che numerose sfide devono essere risolte, innanzitutto a livello pastorale, in alcuni contesti. Rimane soprattutto la questione del ministero di unità a livello universale. Traendo ispirazione dal passato e attingendo all’esperienza presente, come concepire il ruolo del Vescovo di Roma in una Chiesa riconciliata? Nel terzo capitolo di Ut unum sint, intitolato «Quanta est nobis via?», Giovanni Paolo II invitava i pastori e i teologi delle diverse Chiese a cercare, «evidentemente insieme, le forme nelle quali questo ministero possa realizzare un servizio di amore riconosciuto dagli uni e dagli altri» (n. 95). Spetta probabilmente alla Chiesa cattolica fare il primo passo, avanzando una proposta concreta e accettabile «dagli uni e dagli altri» per l’esercizio del ministero dell’unità del Vescovo di Roma a livello universale. Questa proposta potrebbe ispirarsi al principio espresso nel 1982 dal cardinale Joseph Ratzinger in una formula spesso menzionata: «Per quanto riguarda la dottrina del primato, Roma non deve pretendere dall’Oriente più di quello che è stato espresso e vissuto durante il primo millennio». (J. Ratzinger, Les principes de la théologie catholique. Esquisse et matériaux, Paris, 1985, p. 222 (originale: München, 1982). Anche qui, il dialogo con le Chiese ortodosse orientali potrebbe essere pionieristico.
di Hyacinthe Destivelle
Officiale delle sezione orientale del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani
L'Osservatore Romano, 6 juin 2020